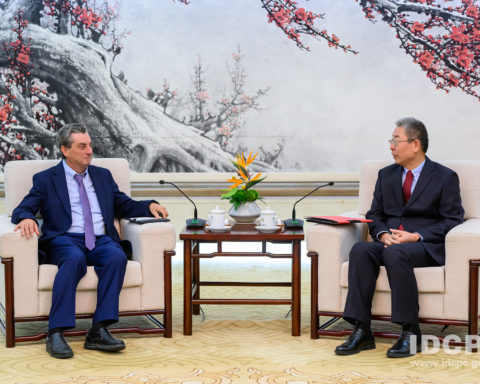In Francia, l’opposizione alla riforma del codice del lavoro e l’occupazione delle piazze da parte del movimento Nuit debout [Notte in piedi, ndt] si sono unite nel rifiuto di una visione striminzita della politica contraddistinta dal dissolversi delle speranze collettive nel buco nero elettorale e dalla marginalizzazione delle questioni di ordine sociale. Si assiste dunque alla fine di un ciclo marcato da rivendicazioni sempre più limitate e mai soddisfatte?
Domandare poco e aspettarsi molto: diciotto anni dopo la creazione dell’Associazione per la tassazione delle transazioni finanziarie e per l’aiuto ai cittadini (Attac), nel giugno 1998, tarda a nascere la tassa infradecimale dallo 0,01% allo 0,1% sulle transazioni finanziarie ispirata dall’economista James Tobin per “gettare della sabbia negli ingranaggi” dei mercati (1). La forma edulcorata che negoziano senza entusiasmo i cenacoli europei apporterebbe solo una frazione del montante inizialmente previsto (oltre 100 miliardi di euro).
Ma, a conti fatti, perché l’obiettivo è stato piazzato così in basso? Perché si è tanto lottato per l’introduzione di una così leggera frizione nel meccanismo speculativo? L’aiuto dello sguardo retrospettivo e gli insegnamenti della grande crisi del 2008 suggeriscono che il divieto puro e semplice di certi movimenti di capitali parassitari era pienamente giustificato.
Questa prudenza nelle rivendicazioni riflette lo spirito di un’epoca in cui il credito di un’organizzazione militante presso un pubblico urbano e coltivato si misurava con la sua moderazione. Con il crollo dell’Unione sovietica, la fine della Guerra fredda e la proclamazione da parte dei neoconservatori americani della “fine della storia”, ogni opposizione frontale al capitalismo di mercato era tacciata d’illegittimità, non solo agli occhi della classe dirigente, ma anche presso le classi medie ormai al centro del gioco politico. Per convincere, si pensava, bisognava mostrarsi “ragionevoli”.
 Certo, la famosa Tobin tax – infradecimale, dello 0,1% al massimo – presenta nel suo insuccesso stesso una virtù pedagogica incontestabile: se l’ordine economico si ostina a rifiutare una modifica così modesta, vuol dire che esso è irriformabile – e quindi da rivoluzionare. Ma per provocare questo effetto di rivelazione, ci si è dovuti prestare a questo gioco e ci si è dovuti piazzare nel terreno degli avversari, quello della “ragione economica”. L’idea di un ordine da contestare con moderazione si era imposta in Francia con tale evidenza che l’iniziativa politica stessa aveva cambiato terreno. Dalla svolta liberale del governo di Pierre Mauroy, nel marzo 1983, non solo la sinistra aveva smesso di avanzare delle proposte suscettibili di “cambiare la vita”, ma i dirigenti politici di tutte le obbedienze hanno fatto piovere sui salariati una grandine di ristrutturazioni industriali, di contro-riforme sociali, di misure d’austerità budgetaria. Nello spazio di alcuni anni, il rapporto con il futuro è cambiato.
Certo, la famosa Tobin tax – infradecimale, dello 0,1% al massimo – presenta nel suo insuccesso stesso una virtù pedagogica incontestabile: se l’ordine economico si ostina a rifiutare una modifica così modesta, vuol dire che esso è irriformabile – e quindi da rivoluzionare. Ma per provocare questo effetto di rivelazione, ci si è dovuti prestare a questo gioco e ci si è dovuti piazzare nel terreno degli avversari, quello della “ragione economica”. L’idea di un ordine da contestare con moderazione si era imposta in Francia con tale evidenza che l’iniziativa politica stessa aveva cambiato terreno. Dalla svolta liberale del governo di Pierre Mauroy, nel marzo 1983, non solo la sinistra aveva smesso di avanzare delle proposte suscettibili di “cambiare la vita”, ma i dirigenti politici di tutte le obbedienze hanno fatto piovere sui salariati una grandine di ristrutturazioni industriali, di contro-riforme sociali, di misure d’austerità budgetaria. Nello spazio di alcuni anni, il rapporto con il futuro è cambiato.
La rivolta degli operai siderurgici di Longwy contro le chiusure delle fabbriche nel biennio 1978-1979 tracciava, con la sua inventiva, il progetto di una contro-società (2). Quella altrettanto importante degli operai del ferro nel 1984 non accarezzava più il sogno della trasformazione sociale. L’ora del combattimento difensivo era suonata, all’inizio degli anni 1980 in Francia e in Germania dopo la messa in riga dell’opposizione extraparlamentare, nel 1985 nel Regno Unito dopo il fallimento del grande sciopero dei minatori. Si tratta da allora di rendere la vita un po’ meno dura, di trincerarsi per diminuire il ritmo e l’impatto delle deregolamentazioni, delle privatizzazioni, degli accordi commerciali, della corrosione del diritto del lavoro. Prerequisito indispensabile, la salvaguardia delle conquiste sociali detta la sua urgenza e s’impone poco a poco come l’orizzonte insorpassabile delle lotte.
Definire ciò che si vuole davvero
Nel 1995, alla veglia dell’elezione presidenziale, anche i partiti che si dicevano comunisti si limitavano ad avanzare delle rivendicazioni come il divieto dei licenziamenti, l’aumento del salario minimo e la diminuzione del tempo di lavoro in un contesto salariale immutato. Spinto dalla Confederazione generale del lavoro (CGT) e da Solidaires, il movimento vittorioso nel novembre-dicembre 1995 contro la riforma della Sicurezza sociale condotta da Alain Juppé sollevava l’ipotesi di un passaggio di testimone da una sinistra politica esangue a una sinistra sindacale rinvigorita. Il seguito fu invece marcato dallo sviluppo del movimento no-global.
 L’approccio internazionale di questo movimento, il suo calendario dei raduni e le sue forme di militanza innovative erano basati su un principio distinto allo stesso tempo dagli scontri ideologici del post-68 e dalle indignazioni morali dei “Restos du cœur” (3), vale a dire il principio della controperizia, basata su analisi dotte e ben fatte, volte a convincere dei potenziali simpatizzanti più famigliari con le aule universitarie che con le catene di montaggio. Con i suoi economisti e sociologi, la sua sigla con il simbolo percentuale e le sue analisi, i suoi anti-manuali e le sue università estive, Attac si dava per missione di popolarizzare una critica fine e preparata dell’ordine economico. Ad ogni decisione del governo che indeboliva i servizi pubblici, ad ogni accordo di libero scambio ideato in gran segreto dalle istituzioni finanziarie internazionali, il movimento rispondeva con numerosi argomenti impeccabili, con decine di opere, con centinaia di articoli.
L’approccio internazionale di questo movimento, il suo calendario dei raduni e le sue forme di militanza innovative erano basati su un principio distinto allo stesso tempo dagli scontri ideologici del post-68 e dalle indignazioni morali dei “Restos du cœur” (3), vale a dire il principio della controperizia, basata su analisi dotte e ben fatte, volte a convincere dei potenziali simpatizzanti più famigliari con le aule universitarie che con le catene di montaggio. Con i suoi economisti e sociologi, la sua sigla con il simbolo percentuale e le sue analisi, i suoi anti-manuali e le sue università estive, Attac si dava per missione di popolarizzare una critica fine e preparata dell’ordine economico. Ad ogni decisione del governo che indeboliva i servizi pubblici, ad ogni accordo di libero scambio ideato in gran segreto dalle istituzioni finanziarie internazionali, il movimento rispondeva con numerosi argomenti impeccabili, con decine di opere, con centinaia di articoli.
Che si tratti di disuguaglianze, di politica internazionale, di razzismo, di dominazione dell’uomo sulla donna, di ecologia, ogni ambito di protesta esibisce da allora i suoi pensatori, i suoi professori universitari, i suoi ricercatori, nella speranza di rendere più credibili le sue scelte politiche con l’unzione della legittimazione accademica. Questa critica, congiunta con la degradazione delle condizioni di vita, ha permesso di mobilitare dei settori della popolazione che non erano organizzati politicamente, ma che si scoprivano vulnerabili a una mondializzazione la cui violenza si concentrava fino a quel momento solo sul mondo operaio.
Il movimento, al quale Le Monde diplomatique fu strettamente legato, avrà convinto della sua serietà, avrà riportato delle vittorie nel mondo intellettuale, nei libri, sulla stampa, avrà persino bucato lo schermo dei telegiornali. Avrà passato un tempo infinito a ripetere delle evidenze mentre i suoi avversari, senza scrupoli e senza sosta, mettevano in opera le loro “riforme”. Come l’aveva suggerito l’ondata contro-culturale degli anni 1970, un ordine politico di destra sa come far fronte ai best-seller di sinistra. Opporre la propria buona volontà accademica alla malafede politica dell’avversario avrà senza dubbio reso la critica più udibile. Ma non più efficace, come ne farà l’amara esperienza, nel 2015, il ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis, i cui ragionamenti accademicamente omologati non pesarono sufficientemente di fronte all’accanimento conservatore dell’Eurogruppo (4).
Sull’affresco ideologico che copre il periodo 1995-2015 coesistono due elementi contraddittori. Da una parte, una ripoliticizzazione fremente, poi ribollente, che si è tradotta in una successione di lotte e di movimenti sociali importanti: 1995 (sicurezza sociale), 1996 (sans-papiers), 1997-1998 (disoccupati), 2000-2003 (picco dell’ondata no-global), 2003 (pensioni), 2005 (rivolte nelle banlieue, campagna contro il trattato costituzionale europeo), 2006 (studenti e precari), 2010 (di nuovo le pensioni), 2016 (diritto del lavoro), rigetto dei grandi progetti inutili (in particolare dal 2012). Dall’altro, delle istituzioni contestatarie indebolite: forze sindacali con le spalle al muro, movimento sociale volto – o dirottato – verso l’analisi accademica, partiti di sinistra radicale impantanati in un gioco istituzionale discreditato. La spinta, le speranze, l’immaginazione e la collera degli uni non si ritrovano negli slogan, nei libri e nei programmi degli altri.
Tutto si svolge come se trent’anni di battaglie difensive avessero privato le strutture politiche della loro capacità di proporre, per quanto nelle avversità, una visione di lungo termine attrattiva ed entusiasmante – quei “giorni felici” che avevano immaginato i resistenti francesi all’inizio dell’anno 1943. In un contesto infinitamente meno cupo, diverse organizzazioni e molti militanti si sono rassegnati a non più desiderare l’impossibile, ma a chiedere l’accettabile; a non più andare avanti, ma a sperare che gli arretramenti si interrompano. Nella misura in cui la sinistra erigeva la sua modestia in strategia, il limite delle sue aspirazioni si abbassava fino alla soglia della depressione. Rallentare il ritmo delle regressioni: compito necessario, ma prospettiva particolarmente poco incoraggiante visto che fa somigliare l’“altro mondo possibile” a quello in cui viviamo, solo un po’ meno degradato. Simbolo di un’epoca, la precarietà ha lasciato il segno sulla lotta ideologica – “precario”, dal latino precarius: “ottenuto con la preghiera”…
Assistiamo alla fine di un ciclo? La germinazione di movimenti osservata su diversi continenti dall’inizio degli anni 2010 ha fatto emergere una corrente, minoritaria ma influente, stufa di domandare solo le briciole e di non raccogliere altro che vento. A differenza degli studenti di origine borghese del Maggio ’68, questi contestatari hanno conosciuto o conoscono la precarietà sin dai loro studi. E contrariamente ai manifestanti degli anni 1980, non temono affatto l’assimilazione al radicalismo dei regimi del blocco dell’Est o al “gulag”: tutti quelli che, tra di loro, hanno meno di 27 anni sono nati dopo la caduta del muro di Berlino. Questa storia non è la loro. Spesso provenienti dalle frange declassate della classe media prodotte in massa dalla crisi, essi fanno sentire nel cuore delle assemblee generali, dei siti internet dissidenti, delle “zones à défendre” (5), dei movimenti d’occupazione delle piazze, e fino ai margini delle organizzazioni politiche e sindacali, una musica a lungo messa in sordina.
Dicono: “Il mondo o niente”; “Noi non vogliamo alleviare la povertà, noi vogliamo l’abolizione della miseria”, come scrisse Victor Hugo; non solo degli impieghi e dei buoni salari, ma il controllo dell’economia, decidere collettivamente ciò che viene prodotto, come viene prodotto, cosa si intende per “ricchezza”. Non la parità uomo-donna, ma l’uguaglianza assoluta. Non più il rispetto delle minoranze e delle differenze, ma la fratellanza che eleva al rango di uguale chiunque aderisca a un progetto politico comune. Non una “ecoresponsabilità”, ma un rapporto di cooperazione con la natura. Non un neocolonialismo economico travestito in aiuto umanitario, ma l’emancipazione dei popoli. Insomma: “Noi vogliamo tutto”, ambizione che travalica ampiamente il campo della visione politica abituale e che molti interpretano come l’assenza di qualsivoglia rivendicazione.
Se piazzare il limite al cielo piuttosto che all’altezza del terreno non aumenta di un pollice le possibilità di riuscita, questo spostamento presenta un doppio interesse. Confinato per il momento ai margini della contestazione e ostile per principio all’organizzazione politica, il ritorno del radicalismo influenza i partiti per capillarità, come nel caso del filo che lega il movimento Occupy Oakland – il più operaio di questo tipo negli Stati Uniti – ai militanti che sostengono il candidato democratico Bernie Sanders nel quadro molto istituzionale della campagna presidenziale. Ma soprattutto, questo radicalismo rinforza le battaglie difensive quando quelli che le conducono in condizioni difficili possono di nuovo appoggiarsi su una visione di ampio raggio e, in mancanza di un progetto precostituito, su dei principi di trasformazione che illuminano l’avvenire. Perché volere tutto, anche quando non si potesse ottenere nulla nell’immediato, vuol dire dover definire ciò che si desidera veramente anziché perdersi dietro a ciò che non si sopporta più.
Si avrebbe torto a vedere in questo cambiamento uno scivolamento dell’azione rivendicativa verso un idealismo incantatorio: esso ristabilisce in realtà la lotta sulle sue basi classiche. Che la sinistra si muova solamente in quanto formazione difensiva è un eccezione dal punto di vista storico. Sin dalla fine del XVIII secolo, i partiti politici, e poi i sindacati, hanno sempre fatto in modo di articolare degli obiettivi strategici di lungo termine con delle battaglie tattiche immediate. In Russia, i bolscevichi assegnano i primi al partito e confinano le organizzazioni dei lavoratori alle seconde. In Francia, gli anarco-sindacalisti integrano “questo doppio bisogno, quotidiano e d’avvenire”. Da una parte, spiega nel 1906 la Carta d’Amiens della CGT, il sindacalismo persegue “l’opera rivendicatrice quotidiana (…) con la realizzazione di miglioramenti immediati”. Dall’altro, “prepara l’emancipazione integrale, che non può realizzarsi che a traverso l’espropriazione capitalista”.
Come osservava lo storico Georges Duby, “la traccia di un sogno non è meno reale di quella di un passo”. In politica, il sogno senza il passo evapora nel cielo brumoso delle idee, ma un passo senza il sogno marcia sul posto. Il passo e il sogno insieme disegnano un cammino: un progetto politico.
A tal proposito, le idee messe al chiodo dalla sinistra e riattivate dai movimenti di questi ultimi anni prolungano una tradizione universale di rivolte egualitarie. In aprile, un pannello destinato a collezionare le proposte dei partecipanti alla Nuit debout, a piazza della Repubblica a Parigi, proclamava: “Cambiare la costituzione”, “Sistema socializzato di credito”, “Revocabilità degli eletti”, “Salario a vita”. Ma anche: “Coltiviamo l’impossibile”, “La nuit debout diventerà la vie debout [vita in piedi, ndt]” e “Chi ha del ferro ha del pane” – dai toni blanquisti.
Speranze di convergenza
Al di là dei socialismi europei, utopico, marxista o anarchico, un sottile filo tematico lega i radicali contemporanei alla schiera delle figure che si aggirano nella storia delle lotte di classe, dall’Antichità greca ai primi cristiani, dai Carmati dell’Arabia (X-XI secolo) ai confini dell’Oriente. Quando, nel 993, il contadino cinese Wang Xiaobo prende la testa di una rivolta a Qingcheng (Sichuan), dichiara che è “stufo della disuguaglianza che esiste tra i ricchi e i poveri” e che vuole “ridurla a beneficio del popolo”. I ribelli applicheranno sul campo questi principi. Quasi un millennio più tardi, la rivolta dei Taiping, tra il 1851 e il 1864, condurrà alla formazione temporanea di uno Stato cinese dissidente fondato su basi analoghe (6). Come in Occidente, queste insurrezioni univano gli intellettuali utopisti, che opponevano delle nuove idee all’ordine stabilito, con i poveri in rivolta decisi a imporre l’uguaglianza a colpi di forcone.
Il compito, ai giorni nostri, s’annuncia senz’altro meno duro. Un secolo e mezzo di lotte e di critiche sociali ha messo in chiaro la posta in gioco e ha posto al cuore delle istituzioni dei punti di appoggio solidi. La convergenza tanto auspicata tra classi medie coltivate, mondo operaio e precari non può aver luogo nei partiti social-democratici morenti, ma solo in quelle formazioni che si doteranno di un progetto politico capace di far brillare di nuovo il “sol dell’avvenire”. La moderazione ha perso le sue virtù strategiche. Essere ragionevoli, razionali, vuol dire essere radicali.
_______________
(1) Si veda Frédéric Lemaire, “En attendant la taxe Tobin”, Le Monde diplomatique, maggio 2016.
(2) Si veda Pierre Rimbert e Rafaël Trapet, “La Commune de Longwy”, Le Monde diplomatique, ottobre 1997.
(3) Servizio di volontariato molto popolare in Francia, simile alla nostra Caritas o al “Tavolino magico”, ndt.
(4) Si veda Yanis Varoufakis, “‘Leur seul objectif était de nous humilier’”, Le Monde diplomatique, agosto 2015.
(5) “Zone da difendere” o ZAD, espressione che definisce quelle occupazioni volte a difendere degli spazi naturali nei quali sono previsti dei progetti con un importante impatto ambientale, ndt.
(6) Si veda “Les traditions égalitaires et utopiques en Orient”, in Jacques Droz (a cura di), Histoire générale du socialisme, vol. 1, Presses universitaires de France, Parigi, 1972.
Fonte: Le Monde diplomatique, maggio 2016
Trad. it.: Damiano Bardelli