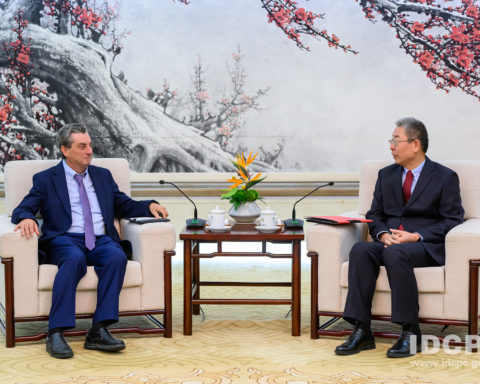Pubblichiamo qui di seguito una libera traduzione dell’articolo di Stéphane Beaud e Gérard Noiriel apparso su Le Monde Diplomatique con il titolo “Impasses des politiques identitaires” (leggi qui l’originale in francese).
Pur avendo le sue radici in una lunga storia, il linguaggio identitario è esploso con i social media e i canali d’informazione 24 ore su 24. Un tempo riservato alla destra, impregna ormai il discorso dei militanti e dei dirigenti politici di ogni schieramento, al punto da trasformare la “razza” in una variabile bulldozer, che distrugge tutte le altre.
La questione razziale è brutalmente tornata d’attualità il 25 maggio 2020, quando le immagini dell’omicidio di George Floyd, ripreso da una passante con uno smartphone, sono state diffuse sui social media e sui mass media. L’assassinio di questo afro-americano da parte di un poliziotto bianco di Minneapolis ha scatenato un’immensa ondata d’emozione e di proteste nel mondo intero. Una moltitudine di attori – militanti antirazzisti, giornalisti, politici, intellettuali, esperti, artisti, scrittori, ecc. – sono intervenuti negli Stati Uniti e altrove per dare la loro opinione su questo crimine e sul suo significato politico.
In Francia, da una quindicina d’anni, la denuncia pubblica dei crimini razzisti o dei fatti alimentanti dei sospetti di discriminazione razziale prende regolarmente nei media la forma di “scandali razziali” (“affaires raciales”, ndt), che si autoalimentano senza fine. Dopo la petizione intitolata “Manifesto per una Repubblica francese antirazzista e decolonializzata”, firmata da 57 intellettuali e diffusa dal sito Mediapart il 3 luglio 2020, il settimanale Marianne ha rilanciato il 26 luglio pubblicando un “Appello contro la razzializzazione della questione sociale”, formato da più di 80 personalità e da una ventina di organizzazioni.
Il paragone delle due petizioni mostra come funziona ciò che Pierre Bordieu chiamava il gioco delle “cecità incrociate”. La critica giustificata delle violenze razziste di certi poliziotti e del “razzismo di Stato” nelle colonie francesi fino alla fine della guerra d’Algeria conduce i firmatari di Mediapart a difendere un progetto politico fondato sulle questioni razziali e decoloniali, occultando i fattori sociali. Inversamente, gli autori dell’appello apparso su Marianne ricordano il ruolo centrale che gioca la classe sociale nelle disuguaglianze che toccano la Francia d’oggi, ma la loro battaglia identitaria, sintetizzata dallo slogan “la nostra Repubblica laica e sociale, un’opportunità per tutti!”, li spinge ad affermare che “il nostro paese non ha mai conosciuto la segregazione”, affermazione che nessuno storico, nessun sociologo serio può sottoscrivere. Questi scontri identitari, dove ogni campo mobilita la sua piccola truppa d’intellettuali, pongono i ricercatori che vogliono difendere l’autonomia del loro lavoro in una posizione impossibile.
Americanizzazione della vita pubblica
Questa razzializzazione del discorso pubblico è stata ampiamente alimentata dalla rivoluzione digitale scoppiata nel corso degli anni 2000. Lo sviluppo straordinario dell’industria mediatica ha portato a termine quella che Jürgen Habermas aveva chiamato la “colonizzazione del mondo vissuto” (1). Queste immense macchine per fabbricare l’informazione sono alimentate 24 ore su 24 da un carburante che sfrutta i giacimenti emotivi sepolti in ciascuno di noi, che ci fanno reagire istantaneamente e istintivamente di fronte alle ingiustizie, alle umiliazioni, alle aggressioni. Il “diversione dei fatti” dell’attualità politica, nato con la stampa di massa alla fine del XIX secolo, ha raggiunto oggi il suo parossismo, sostituendo sempre più all’analisi ragionata dei problemi sociali la denuncia dei colpevoli e la riabilitazione delle vittime.
Queste immense macchine per fabbricare l’informazione sono alimentate 24 ore su 24 da un carburante che sfrutta i giacimenti emotivi sepolti in ciascuno di noi, che ci fanno reagire istantaneamente e istintivamente di fronte alle ingiustizie, alle umiliazioni, alle aggressioni.
Le aziende americane globalizzate che possiedono i social media hanno accelerato brutalmente questo processo, poiché i miliardi di individui che utilizzano queste reti non sono più solamente dei ricettori passivi dei discorsi fabbricati dai media, ma degli attori che partecipano alla loro diffusione e anche alla loro elaborazione. I social media hanno dato così nascita a uno spazio pubblico intermediario che oltrepassa il quadro degli Stati nazione, contribuendo fortemente all’americanizzazione delle polemiche pubbliche, come illustra la rapidità con cui vengono importate espressioni come color-blind (“cieco di fronte al colore”, della pelle), “Black Lives Matter” (“le vite dei neri contano”), cancel culture (“cultura dell’annullamento”), ecc.
Essendo oggi il razzismo uno dei soggetti politici più adeguati a mobilitare le emozioni dei cittadini, si capisce perché la sua denuncia occupi un posto sempre più centrale nei media. Constatare questo fatto, non significa – serve ricordarlo? – negare o minimizzare la realtà del problema, e questo non vieta in alcun modo di constatare allo stesso tempo che le espressioni di forme semplificate di razzismo si moltiplicano anch’esse nei media (2). Le persone originarie dell’immigrazione postcoloniale (paesi del Maghreb e dell’Africa subsahariana) – che appartengono per la maggior parte alle classi popolari (3) – sono state le prime vittime degli effetti della crisi economica a partire dagli anni 1980. Esse hanno subito delle forme multiple di segregazione, che sia nell’accesso all’alloggio, al lavoro o nei loro rapporti con gli agenti dello Stato (controlli d’identità da parte della polizia in base al colore della pelle). Inoltre, queste generazioni sociali hanno dovuto far politicamente fronte al crollo delle speranze collettive portate nel XX secolo dal movimento operaio e comunista.
Queste generazioni sociali hanno dovuto far politicamente fronte al crollo delle speranze collettive portate nel XX secolo dal movimento operaio e comunista.
Data l’importanza assunta dalle polemiche identitarie nel dibattito pubblico, non è sorprendente che una parte di questi giovani possano esprimere il loro rifiuto di una società che non lascia loro alcun posto privilegiando elementi della loro identità personale come la religione, l’origine o la razza (definita dal colore della pelle). Sfortunatamente, i più poveri tra loro sono privati, per ragioni socio-economiche, delle risorse che permetterebbero loro di diversificare le proprie appartenenze e le proprie affiliazioni. È questo che spiega come possano rappresentare il mondo sociale in modo binario e etnicizzato: il “noi” (della comunità, dei giovani neri o arabi, degli esclusi, ma anche sempre di più, sembrerebbe, il “noi” musulmano) versus il “loro” (dei borghesi, dei francesi, dei bianchi, o degli atei, ecc.). Se si vuole spingere fino in fondo la lotta contro il razzismo, si deve anche combattere questa chiusura identitaria, poiché impedisce ai giovani in rivolta di comprendere che la loro esistenza sociale è profondamente determinata dalla loro appartenenza alle classi popolari.
Il linguaggio razzializzante che presenta il colore della pelle come la variabile determinante l’insieme delle pratiche economiche, sociali e culturali dei nostri concittadini distrugge la complessità e la finezza delle relazioni sociali e dei rapporti di potere. Tutte le inchieste sociologiche, statistiche o etnografiche mostrano però che le variabili sociali ed etniche agiscono sempre di concerto e con delle intensità differenti. Se tutta l’arte delle scienze sociali consiste a districare finemente, secondo i contesti (geografico, storico, interazionale), il gioco delle variabili in azione, ciò non toglie che non si possa capire nulla del mondo in cui viviamo se si dimentica che la classe sociale d’appartenenza (misurata dal capitale economico e dal capitale culturale) resta, checché se ne dica, il fattore determinante attorno a cui si costruiscono le altre dimensioni dell’identità delle persone.
La classe sociale d’appartenenza resta, checché se ne dica, il fattore determinante attorno a cui si costruiscono le altre dimensioni dell’identità delle persone.
La prova migliore ci è fornita da coloro che hanno beneficiato di una mobilità sociale che ha permesso loro di accedere alle classi medie (insegnanti, educatori, operatori sociali, artisti d’intermezzo, ecc.) o alle classi superiori (giornalisti televisivi o radiofonici, scrittori, stelle della musica o del cinema, ecc.). La quasi totalità di questi “disertori di classe”, come vengono chiamati, mettono a profitto le risorse loro offerte dalla propria ascesa sociale per diversificare le loro relazioni affettive, professionali o culturali, poiché sanno giustamente che si tratta di un cammino verso maggiore libertà. Perché i discendenti delle immigrazioni postcoloniali che fanno ancora parte delle classi popolari sarebbero costantemente riportati al loro statuto di vittima e privati dei mezzi per accedere anch’essi a questa emancipazione?
Occultando le relazioni di potere che strutturano le nostre società, questi discorsi identitari contribuiscono ad accentuare le divisioni in seno alle classi popolari; ciò che è stato a partire dagli anni 80 l’obiettivo perseguito dalle forze conservatrici per demolire l’egemonia della sinistra. Porre lo scontro politico sul piano razziale presentando tutti i “bianchi” come dei privilegiati, significa incitare questi ultimi a difendersi con lo stesso genere di argomenti. Dato che in Francia i “bianchi” sono la maggioranza, i “non bianchi” sono condannati a restare eternamente minoritari. Credere che degli atti di rimorso alla Jeff Bezos (4) possano condurre gli individui definiti come “bianchi” a rinunciare ai loro “privilegi”, significa ridurre la politica a delle lezioni di morale; ciò che è abituale negli Stati Uniti, e tende a diventarlo anche in Francia.
Porre lo scontro politico sul piano razziale presentando tutti i “bianchi” come dei privilegiati, significa incitare questi ultimi a difendersi con lo stesso genere di argomenti.
Poiché l’esperienza americana è evocata oggi senza sosta quando si tratta di affrontare la questione razziale, non è inutile ricordare l’analisi presentata recentemente dal filosofo Michael Walzer per spiegare il relativo insuccesso del movimento antirazzista nero americano, fallimento che spiega a sua volta perché il razzismo resta un problema centrale negli Stati Uniti. Lui che fu, all’inizio degli anni 1960, uno studente pienamente impegnato nella lotta per i diritti civili condotta dai neri americani è ritornato, 50 anni più tardi, su questo momento fondante del suo impegno politico. Egli ricorda la forza dei legami creatisi nel Sud tra studenti delle grandi università del Nord-Est (Harvard, Brandeis), in particolare da studenti ebrei come lui, e pastori e militanti neri.
Nel bilancio che traccia con il distacco, solleva la questione essenziale delle alleanze politiche da creare nel campo delle forze progressiste: “Noi pensavamo che il nazionalismo nero, anche se era comprensibile, fosse un errore politico: per farsi ascoltare, le minoranze devono impegnarsi in delle politiche di coalizione, gli ebrei lo hanno imparato da tempo. Non potete trovarvi solari quando rappresentate il 10 o il 2% della popolazione. Avete bisogno di alleati e dovete elaborare delle politiche che favoriscano le alleanze. È ciò che ha rifiutato il nazionalismo nero, ed è ciò che l’ha condotto, credo, ad un’impasse (…) Le “politiche dell’identità” hanno preso il sopravvento nella vita politica americana e hanno condotto a dei movimenti separati: i neri, gli ispanici, le donne, i gay. Non c’è stata una chiara solidarietà fra queste diverse forme di lotta per il riconoscimento. “Black Lives Matter”, per esempio, è un’espressione fondamentale della legittima collera dei neri, legata in particolare al comportamento della polizia. Ma gli ispanici non sono trattati meglio; non esiste, da quel che so, un movimento “Hispanic Lives Matter” et non vi è uno sforzo coordinato per la creazione di una coalizione di gruppi etnici per una riforma della polizia” (5).
In passato, per promuovere una causa nello spazio pubblico, occorreva che questa fosse definita e difesa collettivamente da organizzazioni che riunissero un gran numero di militanti. Oggi, è sufficiente che qualche attivista – che si eriga a portavoce di questa o quella rivendicazione senza essere stato incaricato da nessuno – attiri l’attenzione dei media.
Data l’americanizzazione della nostra vita pubblica, si può purtroppo temere che quanto osservato da Walzer si stia verificando anche in Francia. Certo, numerose voci si fanno regolarmente avanti in favore della “convergenza delle lotte”. Eppure, coloro che militano in questo senso devono agire ormai nel quadro del nuovo sistema comunicativo che si è imposto con la rivoluzione digitale degli anni 2000. In passato, per promuovere una causa nello spazio pubblico, occorreva che questa fosse definita e difesa collettivamente da organizzazioni che riunissero un gran numero di militanti. Oggi, è sufficiente che qualche attivista – che si eriga a portavoce di questa o quella rivendicazione senza essere stato incaricato da nessuno – attiri l’attenzione dei media. Da qui la moltiplicazione delle azioni spettacolari, come quelle dei militanti che vietano la messa in scena di spettacoli teatrali in nome della lotta antirazzista. La benevolenza dei giornalisti verso questo tipo d’azioni alimenta delle polemiche che dividono le forze progressiste. Mentre la libertà d’espressione e l’antirazzismo erano fino a qui state sempre associate alla sinistra, questi colpi di mano ultraminoritari finiscono per opporre gli uni agli altri. Aprendo una vera e propria autostrada ai conservatori.
Note
(1) Jürgen Habermas, Théorie de l’agir comunicationnel, Fayard, Paris, 1987.
(2) Gérard Noiriel, Le Venin dans la plume. Edouard Drumont, Eric Zummour et la part sombre de la République, La Découverte, paris, 2019.
(3) Ciò che spiega anche, in maniera diretta, la loro sovrarappresentazione nei fatti riportati dalla stampa locale, negli atti di delinquenza e nella popolazione carceraria.
(4) Riferimento al tweet di Amazon in reazione all’assassinio di George Floyd: “Il trattamento ingiusto e brutale dei Neri nel nostro paese deve cessare” (31 maggio 2020).
(5) Michael Walzer e Astrid Von Busekist, Penser la justice, Albin Michel, coll. “Itinéraires du savoir”, paris, 2020.