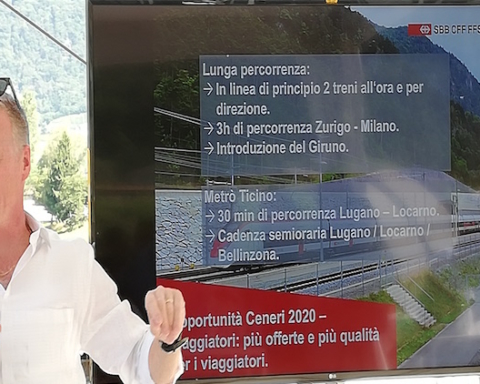Sinistra.ch propone un’intervista a Stefano Azzarà (1) realizzata da Aldo Scorrano, Fabio Di Lenola e Christian Dalenz per conto del Centro Studi Economici per il Pieno Impiego (vedi sito).
Lei ha affermato che «la storia della democrazia è la storia della capacità delle classi subalterne di fare conflitto, di lottare, di riequilibrare i rapporti di forza presenti nella società». Queste classi lo avrebbero fatto unendosi tra loro sulla base di idee, di interessi comuni e di piattaforme politiche avanzate. Questa unione oggi manca ed è ciò che si dovrebbe ricreare, soprattutto nel mondo del lavoro. In buona sostanza bisognerebbe «unire ciò che è stato diviso». Ma come mettere in moto questo processo e con quali modalità?

La risposta a questa domanda non esiste. E se qualcuno pretende di averla in tasca per via di qualche formula alla moda – “populismo” e “politiche del comune” sono oggi quelle più reiterate nelle diverse e contrapposte anime della sinistra , ma in passato i nomi erano diversi – ha capito ben poco dei processi storici, per i quali non esistono leggi simili a quelle che ipotizziamo nel mondo naturale e dunque nemmeno manuali delle istruzioni.
Per come siamo messi, credo comunque che la presa di coscienza reale e non meramente verbale della frantumazione in atto e delle sue ragioni, oltre che della necessità di una ricomposizione di un campo politico di resistenza su basi che siano ad un tempo politiche e sociali (e cioè fondate su una analisi che tenga conto di cosa sono diventate oggi le classi sociali rispetto al periodo della Guerra Fredda), sia già un passo in avanti considerevole rispetto alla totale inconsapevolezza o rimozione che caratterizza ciò che rimane da noi della sinistra storica novecentesca. Ritengo in generale che non dobbiamo aspettarci nuove geniali teorie partorite dalla mente di chissà chi, perché tutto ciò che accade nel mondo delle idee accade quando i tempi e le contraddizioni storiche reali sono mature e interpretabili e non certo per partenogenesi; poiché però gli elementi essenziali della fase in corso sono visibili ormai da molto tempo senza che se ne traggano le conseguenze, ne deduco che è la persistenza di una certa cultura politica, di cui parlerò più avanti, a impedire questo riconoscimento.
La società è articolata in gruppi sociali. E’ vero che questi gruppi sono cambiati rispetto al passato, e che questi spostamenti sono utilizzati spesso in chiave ideologica per sostenere l’estinzione delle classi stesse o la loro acquisita insignificanza sul piano politico, e tuttavia esse ci sono. E come è sempre avvenuto, ogni gruppo di classe occupa una determinata posizione nella divisione del lavoro e svolge una certa funzione in un contesto relazionale. Da qui la sua natura strutturalmente oppositiva, i cui caratteri possono cioè emergere solo in contrapposizione ad altre parti del sistema. Ciascun gruppo è portatore in via costitutiva di bisogni e interessi diversi, che entrano inevitabilmente in collisione dal momento che la ripartizione delle risorse materiali e immateriali che il lavoro sociale collettivo produce è disuguale a monte: funzioni diverse ricevono in maniera diversa in ragione non del lavoro erogato ma della posizione strutturale occupata e in particolare in funzione del ruolo direttivo o esecutivo e del rapporto di questo ruolo con la proprietà (qui si aprirebbe tutto il discorso sul rapporto tra proprietà privata e funzioni del management).
E’ vero allora che oggi non è più sostenibile l’illusione naturalistica per cui le classi subalterne siano spontaneamente orientate a sinistra e da subito interessate alla libertà e al progresso, ecc. ecc. In questo senso aveva almeno una parte di ragione Ernesto Laclau, ormai molto tempo fa, nel fare un bilancio della crisi del movimento operaio dopo l’espansione della società dei consumi e a evidenziare la necessità di un rinnovamento della sinistra nel senso di una sua apertura da una dimensione meramente di classe a una più generale e “populista,” che tenesse conto della differenziazione sociale delle “domande” (i diritti civili). E però, a guardar bene questa mutazione della sinistra è esattamente la teorizzazione ex post di ciò che ai tempi di Laclau stava già avvenendo da anni, come ovvia conseguenza delle trasformazioni sociali, anche senza che nessuno lo teorizzasse. Ed è esattamente ciò che nel frattempo, e cioè da allora sino ai nostri giorni, non ha portato a nessuna evoluzione positiva ma ha al contrario aggravato la frantumazione, perché ne ha semplicemente assecondato il decorso, se non lo ha addirittura accelerato. E’ giusto infatti sottolineare, come con Laclau fanno da decenni quasi tutti i teorici della sinistra radicale di impostazione non marxista, la dimensione della contingenza, visto che non esiste nel campo sociale nessuna necessità a priori. E però riconoscere la contingenza non significa desiderarla e fiancheggiarla programmaticamente nella sua dispersione pluralistica ma semmai prenderne atto cercare di darle un ordine a partire da un progetto politico.
E’ qualcosa di nuovo? Le cose stavano in maniera diversa in passato? No. E’ esattamente questo ciò che è accaduto alle origini del movimento operaio. Non era scritto da nessuna parte che i bisogni della classi subalterne nella società industriale, bisogni reali e oggettivamente inscritti nelle cose, dovessero coagularsi in un fronte di sinistra e in una piattaforma socialista. E’ stata semmai la capacità di alcune organizzazioni politiche di proporre un progetto credibile – un progetto che non fosse arbitrario ma fondato sulla contraddizione oggettiva stessa, e che fosse dunque capace di raccogliere le diverse istanze attorno al loro nucleo di condensazione nel processo di produzione e riproduzione della società – ciò che ha consentito l’autoriconoscimento delle classi subalterne come tali e l’avvio del loro movimento di unificazione. Quel movimento lunghissimo e faticosissimo e mai del tutto compiuto che è stato la premessa del loro rafforzamento e dunque della costruzione della democrazia moderna (1: la democrazia moderna è cosa diversa dalla democrazia come tale, che può convivere anche con la schiavitù e l’imperialismo; 2: chi ha interesse primario nella democrazia moderna sono i deboli e non certo i forti, per cui democrazia moderna è sinonimo di potere relativo delle classi subalterne e dunque è sinonimo di sinistra, a condizione che la sinistra faccia il proprio dovere e non slitti a destra, come in Occidente è avvenuto da parecchio tempo).
Oggi per molti aspetti siamo in una situazione analoga, nella quale abbiamo il compito di ricominciare da zero pur essendo eredi di una lunga storia e dovendo anzitutto imparare da questa storia e dagli errori commessi. Proprio questa storia ci dice che la crisi della sinistra diventa inarrestabile quando, a fronte di un cambio di fase radicale, questa parte politica si dimostra incapace di comprendere i profondi mutamenti intervenuti e ritiene di poter applicare lo stesso comodo schema di gioco del passato, considerato l’unico schema possibile nell’unica realtà possibile. Una realtà divenuta però nel frattempo fittizia, nella quale esiste una sorta di armonia prestabilita tra l’autoposizionamento dei ceti politici che definiscono se stessi di sinistra e la rappresentanza delle classi popolari. E dalla quale, nonostante i proclami rivoluzionari sono esclusi proprio lo scarto e il salto di qualità, tanto che essa si riduce di fatto al meramente esistente.
Ma se in una fase di ascesa complessiva, nella quale il movimento esiste ed è efficace, ha un’identità ed è in grado di operare e esercitare egemonia, sono possibili una serie di tattiche, tra cui quelle di alleanza e mediazione, tutto cambia al cambiare della fase. Quando la fase diventa di ritirata strategica in seguito a una sconfitta storica, tutta la realtà sociale subisce uno slittamento a destra e i processi di subordinazione vengono accelerati, mentre l’egemonia passa al campo avverso. In questa fase, che dura dagli anni Ottanta, continuare come se nulla fosse cambiato per incomprensione o malinteso “realismo politico”, o per abitudine o mentalità politica e culturale, pensando che il consenso popolare sia comunque garantito per natura, è deleterio. Conduce ad assumerci responsabilità che non ci competono. E conduce a perdere credibilità, a causa de una prassi politica che nei rapporti di forza dati entra inevitabilmente in contraddizione con il mandato che emerge da quei bisogni e da quelle domande sociali che ci si proponeva di ricucire assieme.
Proprio perché non c’è nessuna armonia prestabilita tra popolo e sinistra, il proposito di riunificare un soggetto di resistenza o un soggetto antagonista fallisce quando il capitale di rappresentanza viene messo al servizio di politiche che vanno in direzione opposta, o quando viene applicato nel senso della mera riduzione del danno a partire da una fiducia incondizionata nelle identità e nelle appartenenze tradizionali. Non si sopperisce alla mancanza cronica di coerenza e di intransigenza, che nella crisi di egemonia delle élites al comando sono essenziali, agitando il feticcio di un simbolo o di un nome per vellicare le debolezze nostalgiche che albergano ancora in qualcuno – sempre meno – di noi. Al tempo stesso – ed è l’altro pericolo dal quale dobbiamo guardarci -, il proposito di una ricomposizione fallisce anche quando non si comprende che alla crisi delle identità e delle appartenenze non si può rispondere con l’elogio provocatorio delle moltitudini, del nomadismo e dell’ibridazione, perché in politica le identità stabili possono non piacere ma sono essenziali per condurre efficacemente un conflitto dal basso (e chi ha bisogno di unirsi, chi ha bisogno di un partito sulla base di una condivisione e di un patto razionale, bisogna sempre ricordarsene, sono anzitutto i deboli e non certo i forti). E se smantelliamo attivamente quelle identità storiche e culturali – le appartenenze di classe e le appartenenze politiche – che sono già in crisi per conto loro, se invece di rinnovarle e rivivificarle ne neghiamo ogni legittimità in nome del sogno di una sorta di amore universale indistinto, o della spontanea natura cooperativa del General Intellect, oppure le affidiamo alla casualità effimera di ciò che Laclau intende di fatto per “egemonia”, è facile che esse vengano sostituite da altre forme di identità. Le quali pretenderanno invece di essere fortissime, perché fondate su basi naturalistiche e persino biologiche che sono sì immaginarie ma non per questo meno pericolose.
Per unire oggi ciò che è stato diviso è necessario perciò anzitutto comprendere che siamo solo all’inizio di una fase di ritirata strategica che sarà molto lunga. Chi accusa di “purismo” gli intransigenti, sfidandoli sarcasticamente a indicare una via che porti rapidamente alla rivoluzione, esercita un’inutile provocazione. Se c’è qualcuno che pensa che la rivoluzione sia alle porte, o che sia quantomeno possibile un “cambiamento”, è proprio chi si illude che sia possibile “cambiare le cose dall’interno”. Se ragioniamo in termini di cicli storici e andiamo al di là della superficie evemenenziale delle cose, lo spostamento a destra del quadro politico nazionale e ancor prima internazionale, che pure dura dagli anni Ottanta, è invece appena cominciato. E lo smantellamento delle conquiste sociali del XX secolo non si arresterà e non farà prigionieri. L’esito delle elezioni americane, che alla campionessa corrotta delle élites attualmente dominanti contrapponeva il campione impresentabile delle élites concorrenti, il quale – sull’onda della rivolta della piccola borghesia impoverita e incattivita – si sbarazza degli ideologismi del “politicamente corretto” per esercitare direttamente il potere dopo averlo delegato per decenni all’establishment ovvero ai democratici o ai repubblicani, è in questo senso assai esplicativo. E il tifo sfrenato per l’uno o per l’altra che ha lacerato la sinistra europea, la quale sperava di compensare la propria impotenza tramite la vittoria altrui o facendo un dispetto alla propria moglie, lo è altrettanto.
Alla ricerca di sempre nuovi conigli dal cilindro che caratterizza la sinistra attuale, atterrita per aver perso ogni rendita di posizione, va invece contrapposto un altro percorso. Questo significa che dobbiamo predisporci a un lavoro di lunga durata, lungo un orizzonte pluridecennale e con un atteggiamento “nazionale-popolare” e cioè con a partire da quell’ispirazione gramsciana che a me sembra tuttora molto più corretta e utile di ogni richiamo al “populismo”. Chi pensa che basti trovare un leader o un simbolo o una sigla, chi si attacca a scorciatoie come Obama, Tsipras, o Corbyn, o oggi al pavido e subalterno Sanders, chi punta tutto sulle mobilitazioni elettorali, ci costringe a perdere tempo. Ricordiamoci sempre che – anche se può sembrare incredibile – c’è qualcuno che ancora fino a qualche mese fa ha creduto di individuare in Vendola o in Fassina o in Landini o in altri simili a loro delle figure di leader capaci di sopperire alla mancanza di lavoro e organizzazione. Questa è la situazione drammatica in cui siamo finiti.
Ma tutto ciò non deve portarci alla disperazione. Non deve cioè farci dimenticare che la storia c’è e le cose cambiano sempre, perché la dialettica dei rapporti di forza non cessa mai di scorrere nella società. E’ stato facile unire il movimento operaio nel XIX secolo? Per nulla. Si tratta allora di produrre un lavoro oscuro e misconosciuto di portata pari a quello compiuto in quegli anni, per ricucire realtà frammentate in un mercato del lavoro che sembra tornato a situazioni ottocentesche, quando il contratto nazionale non esisteva e lo sciopero era violazione della “libertà del lavoro” ovvero della libertà di sfruttare e farsi sfruttare. Questo lavoro deve svolgersi sul terreno sindacale e su quello culturale, che oggi sono più praticabili. Ma questo lavoro deve porsi il problema di un programma politico, senza il quale il lavoro sindacale e culturale da soli non hanno un orizzonte di lunga durata.
Questo è il punto più doloroso, però: se torniamo sul terreno politico, infatti, il dibattito arretra di almeno due decenni e ci costringe a discutere ancora se fare le alleanze e ricostruire il centrosinistra e dove e in quali occasioni. Siamo cioè lontanissimi, a conti fatti, dalla minima presa di coscienza della tragicità del momento di cui parlavo all’inizio, e ci balocchiamo ancora con figure idealtipiche della nostra impotenza e esistenzialmente nocive come Bersani o Vendola. Se poi dallo scenario nazionale allargassimo lo sguardo a quello internazionale e ai suoi urti latenti, dovremmo solo andare a nasconderci per quanto sono gravi oggi i rischi di conflitto generalizzato. Sono passati quasi trent’anni dalla fine del campo socialista e siamo sempre fermi là: ecco, se non c’è uno scarto sul piano politico che sblocchi la situazione, per altri trent’anni non andremo da nessuna parte. Ma a tal fine è necessario che una o due generazioni totalmente compromesse con il passato – generazioni in senso politico, culturale e di mentalità, non in senso anagrafico – passi la mano. Ci vorrà purtroppo ancora molto tempo e cioè ci vorrà il definitivo esaurimento di ogni speranza di ricostituzione del centrosinistra, che alberga ancora in troppi cuori.
Teniamo conto che per questo obiettivo il contesto è assai difficile non solo per i rapporti di forza assolutamente sfavorevoli ma anche perché le nuove tecnologie digitali – che pure in un ambiente altamente acculturato come quello odierno potrebbero facilitare notevolmente il compito di una ricucitura sociale, mettendoci in una situazione molto più favorevole rispetto a quella dei nostri padri e nonni del XIX secolo -, sono ormai pressoché individualizzate. Esse riproducono perciò un ambiente produttivo di tipo “artigianale” e stimolano perciò forme di coscienza spontaneamente anarchicheggianti, nelle quali ciascuno è in condizione come piccolo produttore di farsi persino il proprio giornale e partito. Purtroppo però anche ciò che rimane dei partiti organizzati non sfugge a questo andazzo. Anche i partitini residui si comportano in questo modo e – ridotti a piccole confederazioni di clan locali che comunicano prevalentemente in rete – invece di unire dividono perniciosamente, perché pretendono che siano tutti gli altri ad annullarsi e a sposare la Giusta Linea. Ciò che essi possono invece fare per dare una mano è una sola cosa: mettersi a disposizione di un processo di convergenza imperniato su pochi punti (analisi storico-materialistica della realtà, autonomia politica rigorosa e orientamento anti-imperialista) e poi sparire per sempre.
Questo processo di separazione (finanche di isolamento e infine di soccombenza) della classe dei lavoratori (in generale, il mondo del lavoro) è stato portato avanti anche mediante la complicità della sinistra (di una particolare classe dirigente) con il grande capitale finanziario, da cui sembra prendere ordini. Come è potuto accadere questo? Si può parlare semplicemente di tradimento o c’è altro da prendere in esame?
Anzitutto bisogna stare attenti a come si maneggia la questione del capitale finanziario in contrapposizione al capitale industriale. Sebbene ci siano certamente differenze e la prevalenza dell’uno o dell’altro risponda a problematiche e contraddizioni interne al modo di produzione nel suo rapporto con l’ambiente storico circostante (il conflitto politico sociale), e sebbene questa gradazione contribuisca a determinare la natura della fase, il concetto stesso di capitale è impensabile senza il credito.

La scissione di questi due momenti, elevati a istanze metafisiche e staccati dalla loro natura processuale, è tipica del pensiero piccolo-borghese. Che a lungo è stato presente anche nel movimento socialista, in quanto rappresentava le istanze dei mestieri tradizionali travolti dai processi capitalistici, di fronte alla crisi e a problemi che quei soggetti sociali non riuscivano a comprendere (una situazione che presenta notevoli analogie con quella attuale). Nella storia delle idee la distinzione tra capitale imprenditoriale e un capitale finanziario cattivo – denaro che genera denaro, ricchezza parassitaria e frutto dell’usura esercitata a danni del lavoro produttivo, un lavoro che caratterizzerebbe il manovale quanto l’imprenditore – è però un cavallo di battaglia di una serie di filoni politici e culturali esplicitamente di destra. I quali già nella seconda metà del XIX secolo, per non parlare di ciò che accadde dopo la crisi del 1929, attaccavano la finanza proprio al fine di salvare la proprietà privata. E i quali, ponendosi in competizione con la mobilitazione socialista di ispirazione marxista, proponevano e propongono una narrazione alternativa a quella della sinistra di classe, accusata di complicità con la finanza mondialista e apolide già a partire dalla sua filosofia della storia progressista.
Oggi, in un’epoca di confusione e di revival delle istanze piccolo-borghesi, non bisogna cadere in questi tranelli già visti in diversi momenti della storia. Ficchiamocelo in testa una volta per tutte, senza farci ingannare dalle sirene di chi sostiene, anche provenendo da posizioni di estrema radicalità, che la vera novità della fase sia il superamento delle categorie di destra e sinistra e l’emergere di un fronte trasversale e “transpolitico” di opposizione al capitalismo neoliberale su basi identitarie naturalistiche (“geopolitiche”). Siamo in una fase molto pericolosa, nella quale la piccola borghesia in via di impoverimento ha revocato il mandato che aveva storicamente conferito alla grande borghesia (a patto che questa ne tutelasse almeno in parte gli interessi) e pensa d’ora in avanti di poter fare in proprio. Ovviamente non ne è capace ed è per questo che questa zona grigia della società è esposta all’influenza di una lotta senza quartiere che si svolge all’interno delle élites, e cioè le classi dominanti, le quali si contendono a suon di miliardi il consenso dei ceti medi impauriti (Trump e Le Pen, che pure molti a sinistra hanno cominciato ad ammirare, sono la personificazione di questa deriva che nasce come rivolta contro i Clinton e gli Hollande ma finisce dritta dritta in una guerra tra poveri). Né ha senso, come molti pasticcioni a sinistra pretendono, pensare che la confusione che dilaga nei ceti medi possa facilmente portare a un fronte popolare di questi settori con le classi subalterne: chi è abituato a fare blocco verso l’alto – i piccoli evasori si sentono ancora borghesi come i grandi banchieri – cerca di fuggire dai poveri, dei quali non sopporta la puzza perché teme di diventare come loro.
Per venire però alla domanda, ritengo che la categoria di tradimento vada esclusa sul piano scientifico. Essa viene usata da sempre nella polemica politica e in questo senso è probabilmente ineliminabile, per quanto sgradevole, sul piano retorico. Ma sul piano della comprensione effettiva dei processi non serve a nulla, esattamente come la categoria di “coerenza” o quella di “estremismo”, o come la coppia categoriale “vecchio/nuovo”, che è meramente formalistica. Chi usa questi concetti, nega che la storia si muova. E nega in sostanza anche il conflitto politico-sociale. Nega cioè che il conflitto politico-sociale serva a qualcosa, che produca effetti, che sposti le contraddizioni in atto e determini i comportamenti e le forme di coscienza. Nega che esista la lotta tra le classi e dentro le classi. E riduce facilmente la storia a un insieme di complotti che vengono prodotti a ripetizione su un piano meramente soggettivistico.
Invece il conflitto politico-sociale, la lotta di classe, esiste. E condiziona forme di coscienza e comportamenti mentre cambia la realtà. E poiché costituisce il tessuto connettivo e l’energia di movimento della società, questo conflitto si dispiega in ogni ambito e in ogni parte della società stessa. Quello che viene deplorato come un tradimento, perciò, non è altro per lo più che la conseguenza di una sconfitta nell’ambito di un conflitto. La sinistra non ha affatto “tradito” il proprio mandato: la sinistra è cambiata, certo, perché è stata trasformata, come inevitabilmente avviene nella storia. Solo che questa trasformazione, essendo figlia di una sconfitta epocale e del peggioramento dei rapporti di forza, si muove nel senso stesso della tendenza generale dominante. E dunque si muove nel senso di uno slittamento a destra complessivo del quadro sociale e politico. Non è la sinistra che va a destra perché ha tradito i poveri: lo fa in quanto ha perso la guerra, ha preso una botta fenomenale ed è tutto il contesto che si spinge e ci spinge in quella direzione.
La lotta di classe va pertanto presa sul serio: non come uno mero slogan declamatorio della domenica ma come il principale strumento di analisi della realtà storica e sociale. E anche il suo esito e le sconfitte che possono maturare al suo interno vanno presi sul serio. E’ ovvio che la sconfitta, che può avvenire per ragioni molto diverse, produce subalternità. E reciprocamente produce l’egemonia del campo avverso. La sinistra è stata dunque sconfitta e egemonizzata a tal punto da venire mutata in destra, nel volto glamour dirittumanista, acculturato e riflessivo della destra.
Una cosa diversa da quanto ho appena detto, e più generale, riguarda invece il fatto che da un altro punto di vista si fa spesso passare per “tradimento” ciò che è semplicemente “apprendimento”. E’ chiaro che un movimento istituzionalizzato è diverso da uno in fusione. E’ chiaro che una forza politica che prende il potere si comporta diversamente da una forza politica che lotta per ottenerlo. E’ chiaro che la dimensione mitologica e religiosa, il purismo, l’idealismo, l’estremismo che possono essere necessari nella fase di accumulazione delle forze, non possono essere utili per gestire fasi successive, nelle quali prevale il compito della ricostruzione di un ordine. In questo senso, la storia del movimento operaio è la storia di continue scomuniche reciproche e di reciproche accuse di tradimento (il cui modello è forse l’accusa di Trotzky verso Stalin di aver tradito l’ideale rivoluzionario, come se la politica non fosse una continua catena di “tradimenti” e come se lui fosse più affidabile…), dietro le quali si nasconde in realtà una scarsa attitudine alla comprensione delle dinamiche storiche. Cosa assai grave per chi si richiama a una teoria, il materialismo storico, che proprio questa comprensione dovrebbe facilitare.
In due libri importanti, Jameson e Harvey descrivono il postmoderno come la filosofia a supporto del capitalismo contemporaneo. A suo giudizio hanno ragione? Qual è la sua posizione in generale sul postmoderno?
Leggo proprio adesso diversi articoli di eminenti editorialisti italiani che sui principali quotidiani nazionali commentano la scelta degli Oxford Dictionaries di dichiarare “Post-Truth” come parola dell’anno. E che deplorano – proprio loro, i principali responsabili della manipolazione industriale del consenso – il postmoderno e il trionfo del motto di Nietzsche secondo cui “non ci sono fatti ma solo interpretazioni”. E rimango sbalordito dal fatto che tutti sembrano improvvisamente diventati nuovorealisti nel nome della logica aristotelica ma anche del rigore, dell’austerità e delle leggi bronzee dei mercati internazionali, mentre fino a ieri le stesse persone inventavano provette di antrace per invadere l’Iraq o mettevano in prima pagina i cani di Kim Jong Un che si erano mangiati lo zio. Jameson e Harvey hanno invece avuto il merito – in un’epoca nella quale il postmodernismo impazzava senza opposizioni e la difesa dei fondamenti filosofici della modernità era assimilata a un’ingenua apologia delle Grandi Narrazioni o, scimmiottando Nietzsche, alla mera secolarizzazione di un discorso religioso – di dire cose eretiche e scandalose, che turbavano l’ideologia dominante. Lo hanno fatto, inoltre, in nome di una teoria politica, il marxismo, che sembrava il primo cadavere provocato dall’avvento del postmodernismo. Lo hanno fatto, infine, in lingua inglese e cioè nella lingua dell’Impero, quel soggetto politico e ideologico che più di ogni altro ha contribuito alla creazione della nuova koiné postmoderna.
Quando si parla di postmoderno, soprattutto in ambito accademico, i colleghi più interni al discorso dominante cercano subito di intimidirti chiedendoti di tirare fuori i nomi. E poi cercano di inchiodarti facendo ricorso alla frantumazione specialistica del campo filosofico, dicendo cioè che la realtà “è più complessa”, che molto diverse sono poi le proposte di Foucault o Deleuze o Vattimo o Derrida o questo o quello, e che confondere queste cose non è rigoroso, non è scientifico, non è serio, è propaganda politica, e via dicendo. Si tratta di strategie retoriche difensive che sono in auge dai tempi della sofistica antica. In realtà, queste differenze, che pure sono presenti, non confutano proprio niente rispetto alla critica del postmodernismo. Si possono avere anche le posizioni più diverse e contrapposte, infatti, ma condividere il terreno di alcuni fondamenti filosofici essenziali. Quando un complesso egemonico agisce in maniera incontrastata dopo una vittoria di sistema, occupa tutto lo spettro del campo ideologico e può persino mettere in scena feroci contrapposizioni dentro il nulla. Ed è esattamente quello che succede da decenni con il postmodernismo. Il postmoderno è in sostanza l’aspetto culturale della svolta neoliberale, come il revisionismo ne è l’aspetto storiografico. Dalla metà degli anni Settanta, come sappiamo, la fase si è invertita perché nel conflitto politico-sociale a un lungo ciclo di ascesa delle classi subalterne è seguita una controffensiva delle classi dominanti. Questa transizione si è svolta certamente su più piani e ha avuto una molteplicità di aspetti, dalla produzione alla sfera istituzionale. Ma sarebbe stata impossibile senza una parallela transizione culturale.
Quest’ultima transizione è consistita prevalentemente nella critica e nello smantellamento dei fondamenti filosofici della modernità. Ovvero di quelle condizioni culturali che hanno creato il contesto per un progetto di emancipazione consapevole, collettivo e organizzato, e che già Nietzsche si era proposto programmaticamente di annientare, seguito in ciò da Heidegger. Non posso fare qui un discorso sistematico. Ma posso accennare al fatto che si trattava di mettere in discussione la concezione del tempo, a partire dall’idea di progresso (considerata oggi un cane morto di cui vergognarsi anzitutto dalla sinistra). Si trattava poi della concezione dell’uomo, di cui viene negato il concetto universale (e ancora una volta è la sinistra, soprattutto quella femminista, ad aver rivalutato il differenzialismo e il nominalismo tipici delle destre). E della contestazione della progettualità universale in quanto tale. Si trattava infine del ruolo della ragione e della sua potenza conoscitiva e connettiva. Sono tutte cose che hanno parecchio a che fare con la costruzione del movimento socialista e senza le quali il processo di unificazione che ha conferito ai subalterni la forza politica di configgere dal basso contro le classi dominanti non sarebbe stato minimamente pensabile (voglio vedere qualcuno disposto a farsi sparare o mettere in galera per ragioni politiche se non crede nel Sol dell’Avvenire o in qualcosa di simile). E sono cose che, non a caso, sono state contestate in corso d’opera sia dal pensiero conservatore che da quello liberale, prima di essere rivalutate dopo la Seconda guerra mondiale anche in altri ambiti politici.
In questo passaggio la sinistra ha avuto un ruolo passivo ma centrale. Sono stati proprio gli intellettuali di sinistra a elaborare infatti le posizioni postmoderne, immaginandole come una risposta alla crisi contemporanea della libertà. Lo hanno fatto per via dei cambiamenti della società che abbiamo già visto: una società affluente è più attenta all’individuo di una in via di sviluppo ed è giusto che sia cosi. Lo hanno fatto però anche a partire da una riflessione sul Novecento e sui fallimenti delle promesse della modernità. In questo senso il discorso postmoderno non va per nulla ridicolizzato, come spesso avviene per reazione nella sinistra estrema di classe. Esso nasce da un’esigenza reale e incontestabile: il riconoscimento del ruolo dell’individuo dopo una lunghissima epoca nella quale esso era stato inevitabilmente sacrificato al primato del genere o dei grandi collettivi.
Chi ridicolizza questa esigenza in nome di un pensiero virile che parla come mangia non solo non capisce nulla di quanto è successo, ma al mito libertario dell’autonomia assoluta finisce spesso per contrapporre l’incubo di un controllo autoritario della società e di una sottomissione dell’individuo che è in contraddizione con tutta la storia della sinistra e che si colloca perciò a destra. Non è questo ciò che ci deve interessare, anche se è vero che il postmodernismo teorico è insopportabile nella sua puzza sotto il naso. Ed è anche vero che in nome di un malinteso “individuo” c’è stata in passato un’offensiva politica che ha scatenato una vera e propria Guerra Fredda culturale, facendo leva esplicitamente sulle pulsioni idealistiche e puristiche della sinistra non comunista e di quella “trotzkista” in senso lato.
Lasciamo da parte questi casi, però. In generale, va detto che le pur ottime intenzioni dell’intellettualità della sinistra radicale sessantottina e post-sessantottina, l’intenzione di valorizzare la libertà individuale e il punto di vista particolare contro un’universalità che spesso è stata sinonimo di terrore e imperialismo, è venuta a cadere nel pieno di un conflitto, anzi di una vera controffensiva dall’alto. Le idee postmoderne, cioè, sono state sfortunatissime – ahiloro e ahinoi – e si sono affermate proprio nel momento più sbagliato possibile. Quando era in corso una rivincita delle classi dominanti, le quali miravano già in maniera esplicita a recuperare il terreno perduto in oltre un secolo di redistribuzione democratico-moderna della ricchezza materiale e immateriale e del potere. E le quali sono facilmente riuscite a riassorbire il discorso postmoderno nell’ambito di una rivoluzione passiva di enorme portata che è ancora in corso.
Non ha senso, perciò, rivolgere insulti compensativi al postmodernismo e alla sinistra postmoderna senza capire cosa avesse motivato queste posizioni. Si tratta invece di spiegare a coloro che hanno a cuore l’individuo, e che non sopportano le rigide categorizzazioni di classe, che le pur legittime istanze del postmodernismo – se non vogliono essere un cavallo di troia della destra come sono state sinora – devono essere ricondotte esse stesse al progetto moderno di emancipazione come progetto consapevole, collettivo e organizzato. E devono contribuire al suo compimento laicizzando gli elementi di religiosità presenti nel mito rivoluzionario ma senza rinunciare alla tensione universalistica che lo innerva. La modernità è infatti incompiuta, come ha spiegato da molto tempo persino una figura assai moderata e noiosa come Habermas. E finché non riprenderà il processo della sua costruzione, la stessa libertà individuale inevitabilmente soffrirà, perché alla lunga non esiste libertà individuale senza libertà collettiva, non esiste libertà negativa senza quella positiva. Anche l’apparente assolutezza della libertà individuale oggi è assai effimera: da un lato essa è rovesciata nell’indifferenza dell’intercambiabilità che toglie responsabilità all’individuo ma sottrae anche senso. Dall’altro è rovesciata nella legge della giungla, nella quale alla libertà apparente di tutti, che per lo più inizia e finisce nel consumo di merci o di presunte esperienze di distinzione, si contrappone la libertà reale di uno solo.
Si tratta di questioni che rimangono all’ordine del giorno anche se è sempre più viva oggi la tendenza a dichiarare l’esaurimento del postmodernismo. In realtà, per come vedo io le cose, il postmodernismo è finito e delegittimato se facciamo riferimento alle proposte programmatiche postmoderne di cui erano ricolmi gli anni Ottanta e Novanta e alle quali nessuno oggi può seriamente credere pena il ridicolo. Ma questa fine coincide con una disseminazione e fa seguito al consolidamento di un senso comune rassegnato, tale per cui i presupposti del postmodernismo sono più vivi e attivi che mai proprio quando in apparenza tutti si vergognano a dichiararsi postmoderni. Che cos’è in realtà la presunta opposizione “identitaria” al postmodernismo, quella ad esempio che viene da destra e che vorrebbe ripristinare il primato improbabile dei valori tradizionali nel 2016 creando un vasto fronte trasversale alla destra e alla sinistra, se non un detournement tutto postmoderno e pasticciato di ciò che rimane delle identità politiche del Novecento?
La cosiddetta “marea rosa” latinoamericana (ovvero, l’ondata di governi di sinistra cominciata a fine novecento con la salita al potere in Venezuela di Hugo Chavez) sembra volgere al termine. A suo giudizio, perchè sta avvenendo questo? Quali sono stati i limiti di queste esperienze?
Intanto va chiarito un aspetto. In continuità con il terzomondismo di un tempo, che si contrapponeva al mito dell’Urss, l’attenzione verso l’America Latina ha spesso a che fare con l’esotismo e il populismo tipici della sinistra etnocentrica europea. Un esotismo che a sua volta è legato anche a una concezione postmoderna della storia e delle soggettività. Di contro alla sinistra ancora classista, universalista, triste, monistica, economicista, gerarchizzata, tipica del panorama socialista europeo, viene raccontata la finzione di una sinistra tropicale variopinta e ballerina, pluralista, allegra, comunitaria. Non è solo una questione di tipologia dei gruppi. E’ anche un’idea di sviluppo storico: l’idea cioè che si possa arrivare al socialismo senza lavorare, saltando lo sforzo della modernità, semplicemente con un revival delle comunità originarie e in questo caso di quelle indigene, nonostante la loro arretratezza produttiva fosse necessariamente anche ristrettezza di orizzonti culturali. E’ un socialismo ideale, antieconomicistico, umanistico, populista, anarchicheggiante, questo che sogna di comuni agricole e Vere Zasulic. Ed è ontologicamente in imbarazzo con il potere, tanto che sta con i deboli e i poveri a patto che costoro non osino tentare di diventare più forti e ricchi attraverso la conquista delle leve politiche (come è avvenuto nei confronti dei comunisti cinesi).
Ebbene, questa visione – che nasconde in realtà un senso di superiorità degli occidentali così forte da sovrapporre un desiderio alla realtà – è sbagliata. Il ciclo progressista in America Latina nasce certamente dalla questione sociale e da un lavoro decennale dei movimenti politici e sociali di quei paesi. Ma nasce anzitutto da secoli di dominazione imperialistica yankees nel cortile di casa, prima e dopo la Dottrina Monroe. E nasce perciò dalla legittima, identitaria, nazionalistica e tradizionalissima reazione al dominio altrui nel momento in cui la politica americana ha una crisi di overstretching e non riesce a controllare tutto il vasto campo dell’Impero. Questo ciclo è dunque il figlio non della nuova politica postmoderna dei movimenti in stile Laclau, che poi è la solita New Left che conosciamo da una vita, ma della vecchissima questione nazionale e coloniale. Una questione i cui termini sono assai chiari ai latinoamericani ma molto meno agli europei, i quali pure pretendono di farsi campioni dell’America Latina e di fare anche la lezione ai suoi soggetti politici.
Detto questo, con buona pace di qualche buontempone che ha immaginato di identificare nei BRICS l’imminente costruzione di un nuovo Campo Socialista delle Nostalgie, anche in America Latina il ciclo progressista pare essere alle corde. L’Argentina. Il Brasile. Il Venezuela. I problemi in Bolivia. La sfida più ardua per Cuba. La ragione principale di questa crisi è la riscossa dell’imperialismo statunitense: su questo non c’è dubbio e bisogna essere sempre rigorosamente dalla parte di quei governi che a questa offensiva cercano di resistere. E però, visto che gli Stati Uniti fanno alla fine il loro mestiere e che questo si sapeva sin dall’inizio, credo che siano più interessanti e istruttive, per chi voglia imparare, altre due ragioni alla base di questa crisi.
La prima riguarda un aspetto già visto: di fronte all’esperienza del governo, i movimenti politici devono crescere, devono saper apprendere. Lo scontro tra la teoria e la prassi politica non è mai indolore. Il corso del mondo non è mai l’ambiente più confortevole per la legge del cuore. Chi pensa che politica sia la miracolosa realizzazione di ideali purissimi, non agirà mai politicamente. Perché la politica deve sempre tener conto dei rapporti di forza e della realtà data, della natura oggettiva delle contraddizioni. Questo atteggiamento idealistico non è presente però soltanto in Europa. Anche in America Latina è assai diffuso. Conosco la realtà brasiliana meno peggio di altre e ho sentito spesso il racconto di cose che non pensavo possibili in realtà che consideravo più sane. Basti del resto ricordare un dato di fatto: alle ultime elezioni, contro Dilma si è candidata una esponente dell’inutile partito dei Verdi, che in precedenza aveva fatto parte della coalizione di Lula ma che in nome della “vera sinistra” aveva criticato le debolezze sociali del governo del PT. E che faceva finta di non accorgersi nemmeno di favorire con la sua candidatura le destre neoliberali (si badi bene: questo argomento dell’apprendimento ha natura dialettica e va perciò sempre commisurato alla situazione concreta e cioè all’andamento del conflitto e al diagramma dei rapporti di forza; in Italia viene infatti spesso usato da chi pensa di trovare spazi più ampi attraverso una politica di alleanze o di entrismo: la differenza sta però nel fatto – decisivo – che in Italia c’è un processo dominante regressivo che va a destra e smantella Welfare, mentre in Brasile c’era un processo progressivo che, pur tra mille contraddizioni, andava a sinistra e il Welfare lo costruiva).
Ma è solo nella società civile o tra i militanti e simpatizzanti che c’è stato questo deficit politico? No, anche nei quadri dirigenti politici. Anche loro sono stati restii all’apprendimento. Non penso al Brasile, in questo caso, che è stato investito da un’offensiva esplicita che ha fatto ricorso a mezzi illegali. Penso piuttosto al Venezuela, che per quanto ne so ha perso una grande occasione. Invece di apprendere dal passato, dalla storia del campo socialista, e capire che obiettivo fondamentale in questa fase per un paese subalterno è lo sviluppo delle forze produttive, il conseguimento di quell’indipendenza economica che può garantire quella politica, per quello che io posso capire il Venezuela ha sviluppato politiche assistenziali assai generose ma rese possibili unicamente dalla presenza del petrolio. E’ chiaro che la manipolazione dei prezzi guidata dagli Usa ha a un certo punto messo in ginocchio la politica venezuelana. Che senza il carisma di Chavez si è andata logorando ed è oggi alle soglie di una guerra civile per via delle pulsioni golpiste delle destre filo-americane.
Per quello che posso capire, la fine del ciclo progressista in America Latina sconta dunque i problemi generali della sinistra, che sono problemi di portata mondiale.
Il giudizio sull’Unione europea per i comunisti (e per la sinistra) riflette la contraddizione (apparente) tra internazionalismo e via nazionale al socialismo. Abbiamo due blocchi: da una parte c’è l’idea di una lotta a livello europeo per imporre politiche economiche alternative mentre dall’altra parte c’è chi si schiera per una rottura anche unilaterale. Come va interpretato l’internazionalismo di Marx? E quale giudizio va dato sull’Unione europea?
E’ una questione assai complessa, dai molti risvolti dialettici, che poco si presta – come invece di fatto accade – alle semplificazioni e alle tifoserie di chi pur avendo un nobile lignaggio si è ridotto ormai all’impotenza. Sintetizzando si può però dire che bisogna essere rigorosamente inter-nazionalisti. E cioè che bisogna tener ferma la centralità della questione nazionale in questa fase politica, senza però mai contrapporla all’esigenza di una costante apertura universalistica delle identità storicamente determinate e alla spinta oggettiva all’autoriconoscimento del genere umano e alla costruzione delle istituzioni che sono adeguate a questa essenza generica.
Il punto da cui partire è a mio avviso questo: esiste una tendenza secolare all’aggregazione di grandi spazi geopolitici che è connessa alla fine del feudalesimo e all’affermazione del modo di produzione capitalistico, con la conseguente dilatazione degli scambi, e che riguarda in primo luogo proprio la piattaforma europea. Questa tendenza si è affermata molto presto nel corso dell’età moderna, quando ancora la costruzione degli Stati nazionali non era compiuta, come non era compiuta nemmeno la costruzione delle forme politiche rappresentative. Eppure già con Napoleone, quando non esisteva ancora la grande fabbrica e le comunicazioni via telegrafo erano appena iniziate, era chiaro il tentativo di aggregare la piattaforma continentale. Un tentativo che già allora le potenze marittime, e cioè in questo caso l’Inghilterra, avevano contrastato; e che è fallito perché a tentare l’avventura era stata una potenza “laterale” come la Francia. Già agli inizi dell’Ottocento, insomma, la Grande politica aveva una dimensione sovranazionale e continentale, perché già l’avvio della modernità, innescando una moltiplicazione delle reti di traffico e di comunicazione, aveva provocato un drastico allargamento degli orizzonti del genere umano e della sua attività produttiva.
Per chi deplora lo sviluppo delle forze produttive in una prospettiva populistica e pauperista, o dal punto di vista di una introvabile “tradizione”, tutto questo è qualcosa di mostruoso. A mio avviso, invece, si tratta di un pezzo di quella straordinaria rivoluzione che costituisce la modernità. Lo sviluppo produttivo, che accorcia le distanze e mette i popoli in contatto favorendo la circolazione del pensiero, è anche uno sviluppo intellettuale e “spirituale”. Sotto questo aspetto bisogna essere rigorosamente modernisti come erano Marx e Engels nel Manifesto ma anche Lenin nel richiedere l’elettrificazione del territorio sovietico: autarchia, radicamento, chiusura, paura nei confronti dell’ignoto sono sinonimo di arretratezza culturale e antropologica, di ottusità, di provincialismo, di scarsità di bisogni e dunque anche di talenti. Il progetto moderno di emancipazione contiene in sé, in questo senso, il progetto dell’unità del genere sancita nel concetto stesso di uomo. La costruzione del genere umano coincide, perciò, con la costruzione di uno spazio unitario che tende a dilatarsi fino al perimetro del mondo stesso. Non bisogna avere paura di questo processo, perché altrimenti di nostalgia in nostalgia staremmo ancora a rimuginare su quanto fossero belli i tempi degli Assiri e dei Babilonesi, dei Greci e dei Romani (c’è chi lo fa), mentre il dinamismo accompagna homo sapiens sin dalla sua comparsa sulla terra.
Questo significa che i processi di superamento degli Stati nazionali e di convergenza sovranazionale vanno sempre salutati positivamente? Non è così e quanto ho detto sinora non è sufficiente, perché una volta esposti i principi generali bisogna sempre vedere a che punto siamo nella storia e cioè nella situazione concreta. Mentre questo retroterra di filosofia della storia, che pure è corretto e che io stesso condivido, induce molto spesso molti gli intellettuali di sinistra ad accontentarsi dei principi generali e a sospettare di ciò che sembra contraddirli. Come appunto lo Stato nazionale, il quale viene assimilato tout court al nazionalismo. Il quale – nella dimenticanza del contesto storico reale – viene a sua volta identificato tout court con la politica di potenza e l’egemonismo. Le cose però non stanno per nulla così. La natura progressiva della mondializzazione alla quale alludevo prima non deve fare dimenticare il semplicissimo fatto che essa ancora non c’è, ovvero non è compiuta. E che sebbene quello scenario sia affascinante, la legittima ricerca dell’universalità, se non vuole metter capo a una forma astratta, deve sempre fare i conti con la mediazione. E dunque, nel caso che ci riguarda, con il fatto che non è ancora affatto tramontata l’epoca degli Stati nazionali, i quali sono invece tuttora vivi e sono coinvolti in una rete di rapporti di forza i cui sviluppi non sono indifferenti rispetto agli esiti di quella stessa mondializzazione che ci è tanto cara. Per amore del futuro, si rischia altrimenti di sacrificare il presente e di prendere posizioni sbagliate. Nelle quali l’universalismo si rovescia nel suo contrario e lo stesso futuro viene compromesso perché viene ipotecato a monte da interessi di parte.
Il concetto di nazione, va allora detto, è progressivo e di sinistra e si afferma con la Rivoluzione francese in coincidenza con il superamento dell’Ancien Régime e della concezione conservatrice e patrimoniale dello Stato. Ancora alla fine del XVIII e nel corso del XIX secolo il concetto di nazione e il nazionalismo, ad esempio in Herder, nel primo Fichte e in numerosi altri autori da loro in avanti, hanno a che fare con la questione dell’autodeterminazione dei popoli, della democrazia internazionale, della costruzione del concetto universale di uomo e via dicendo. E’ solo con l’epoca degli imperialismi che il nazionalismo diventa aggressivo e la sua dialettica si inverte. Ma come ha notato Hannah Arendt, l’imperialismo – quello nazista e quello fascista, ad esempio – rappresenta esattamente la confutazione della categoria di nazione e non ha niente a che fare con il nazionalismo, che è un fenomeno progressivo.
Se nel movimento socialista delle origini è ancora presente un afflato cosmopolitico che è retaggio dell’influenza borghese e eredità dell’astrattezza illuministica della Rivoluzione francese e del napoleonismo, quando questo movimento assume un orientamento marxista ogni ingenuità viene in tal senso superata. Sappiamo quanto Marx e Engels fossero attenti alla questione nazionale, che rientra in pieno nell’ambito della lotta di classe (la Polonia, l’Irlanda…). Sappiamo che anche Gramsci e Lenin avevano ben chiara questa funzione della questione nazionale. E’ per questo che io, come dicevo prima, preferisco parlare di inter-nazionalismo piuttosto che di internazionalismo tout court. Del resto, è lo Stato nazionale e solo esso la cornice storica della democrazia moderna. Ed è sempre lo Stato nazionale ad aver rappresentato il contesto nel quale le classi subalterne hanno ottenuto il massimo delle loro conquiste. Non parliamo poi del nesso che sussiste tra statualità e diritti dell’uomo (diversi dai “diritti umani” di cui si parla oggi). Un nesso che diventa chiarissimo al rovescio oggi, quando alle masse di rifugiati privi di Stato viene negato anche ogni riconoscimento (ricordiamo, nuovamente, Hannah Arendt e quanto diceva a proposito della condizione di apolide subito dopo la Seconda guerra mondiale).
Ora, per tornare ai problemi di oggi, è evidente che anche il processo di costruzione del genere, quel riconoscimento della comune umanità che è il cuore del progetto moderno e che possiamo chiamare “mondializzazione”, non è mai stato privo di contraddizioni e ha coinciso per gran parte della storia occidentale con il colonialismo, il quale se ne è fatto portatore per eterogenesi dei fini. Tuttavia, questa mondializzazione del genere, persino con le sue contraddizioni, va distinta nettamente e in via di principio da quanto sta accadendo sotto i nostri occhi. E cioè da un progetto solo in apparenza simile che chiamiamo “globalizzazione” e che consiste invece nel deviare la costruzione del genere nel senso dello specifico progetto dell’imperialismo e dell’”internazionalismo” statunitense. Il quale già dalla fine della Seconda guerra mondiale ha costruito un’area di libero scambio in funzione geopolitica prima ancora che geoeconomica, con l’obiettivo di isolare la Russia sovietica e il campo socialista. La globalizzazione di cui tutti parliamo dagli anni Novanta in poi non è perciò la mondializzazione, la costruzione del genere, ma è la sua negazione determinata, è l’immagine del mondo che esce dalla vittoria del progetto egemonico statunitense. Tanto che da quel momento “internazionalismo” diventa una parola edulcorata che copre le aspirazioni imperialistiche degli USA e dell’Occidente (in posizione subordinata). Di questa globalizzazione particolaristica fa parte anche il processo di unificazione europea nelle modalità specifiche che esso ha assunto nel secondo dopoguerra e cioè in una fase storica in cui, dopo la sconfitta della reazione nazifascista, le nazioni europee sono divenute di fatto semicolonie statunitensi.
Alla negazione determinata non si contrappone però una negazione assoluta ma un’altra negazione determinata. La contingenza fenomenologica imperialistica del processo comporta l’insignificanza del processo di mondializzazione stesso? Non è così. Si tratta perciò di distinguere con chiarezza la tendenza di lunga durata, che è progressiva e coincide con la costruzione del genere, dalle sue modalità contingenti che sono legate ai rapporti di forza vigenti. La mondializzazione e umanizzazione come processi sono infatti dei campi di forze che possono essere deformati secondo progetti politici ben precisi e ben precise gerarchie. Ed è chiaro, sotto questo aspetto, che l’architettura di Maastricht è stata sin dall’inizio orientata in senso politico e sociale, così che essa va di per sé intesa come un grandioso progetto di ri-sottomissione del lavoro e di abbassamento del suo costo. Un progetto che cade al termine di una fase assai ampia di lotta di classe e che viene elaborato al fine di consentire alla piattaforma continentale, aggregata in posizione subalterna, di svolgere un ruolo complementare nelle gerarchie internazionali di divisione del lavoro di marca statunitense. Inoltre, nel processo di convergenza europea gli Stati nazionali, come ho detto prima, non svaniscono affatto: semplicemente alcuni Stati nazionali e uno in particolare costruiscono un ambiente ideale per egemonizzare gli altri e occupare una posizione privilegiata nella catena imperialistica.
In una prospettiva dialettica, si tratta perciò di respingere questo progetto politico e di riproporre con forza la questione nazionale. Ma si tratta di farlo per le ragioni giuste, e cioè in nome della democrazia moderna e non in nome di forme politiche autoritarie o post-democratiche. Si tratta cioè di riaffermare la centralità dello Stato-nazione nel suo nesso con la questione della democrazia tra le classi e tra i popoli e con la questione sociale. E si tratta al tempo stesso di farlo senza contrapporre la questione nazionale così intesa al progetto di mondializzazione e costruzione del genere, come invece avviene per lo più da parte degli avversari del processo di unificazione europea (tra i quali c’è chiarissima un’egemonia di destra sociale che si coagula principalmente sul terreno del contrasto alle migrazioni).
Conosciamo tutti le conseguenze devastanti sul piano sociale del processo di convergenza monetaria e conosciamo anche quante illusioni, alla fine della Guerra Fredda, sono state spacciate da una classe dirigente orientata prevalentemente a sinistra. Va tenuto conto, inoltre, che l’offensiva dall’alto contro le classi subalterne, quell’offensiva che è passata per la devoluzione dei poteri nazionali al fine di aggirare i vincoli redistributivi (in termini di ricchezza e di potere) della democrazia moderna e le garanzie che questa forma politica assicurava fasce sociali più deboli, si è accompagnata a un altro fenomeno. Si è accompagnata cioè a una grande rivoluzione che ha investito i paesi un tempo colonizzati dall’Occidente, i quali hanno fatto il loro ingresso nella modernità e si sono sviluppati a ritmi vertiginosi, sfruttando legittimamente il vantaggio competitivo che l’apertura delle frontiere commerciali dava loro in forza del basso costo del lavoro.
Si tratta di una rivoluzione di enorme portata e dal carattere decisamente progressivo, a meno che non vogliamo rimpiangere i tempi del colonialismo come sempre più persone in effetti fanno. E’ chiaro però che questa concomitanza ha ristretto ancora di più la quota di ricchezza alla quale l’Europa può aspirare e ha di conseguenza inasprito ulteriormente in questo continente la lotta di classe dei ricchi contro i poveri. I quali hanno finito per pagare il declino relativo dell’Occidente nei riguardi del resto del mondo. Da qui la concentrazione della ricchezza verso l’alto e il crescente impauperimento verso il basso, aggravato dalla concomitanza della terza ondata di deportazione capitalistica della forza-lavoro e da una conseguente guerra interna alle stesse classi subalterne. Da qui, inoltre, la rottura dell’alleanza tra la piccola borghesia e la parte dominante e “illuminata” della grande borghesia, con l’emergere di pulsioni protezionistiche che possono essere facilmente cavalcate mediante il mito dell’invasione e della sostituzione kalergiana dei popoli bianchi da parte dei “negri” e dei “beduini”. Pulsioni che convergono alla fine in una critica della politica (la Casta), la quale nasconde in realtà una critica della democrazia moderna e del ruolo redistributivo dello Stato. Questa critica ha travolto al contempo i partiti politici moderni, che erano già messi assai male per conto loro, e ha consentito l’esplosione delle tendenze cosiddette “populiste”, con le quali la piccola borghesia, nell’illusione di fare da sé, va alla ricerca di un capo carismatico e di un facile capro espiatorio che renda ragione della nostra sfortuna e infelicità.
La perdita di ricchezza da parte dell’Europa in forza dell’ascesa del mondo ex coloniale deve spingerci a dichiarare guerra a quei paesi in nome della questione sociale, come volevano i social-imperialisti della prima parte del Novecento? I conflitti nei segmenti inferiori del mercato del lavoro devono indurci a sparare sui barconi dei migranti? Al contrario di coloro che respingono il processo di mondializzazione proprio in quanto questo è sinonimo di costruzione del genere e di eguaglianza, e che propugnano il ritorno dello Stato nazionale solo in virtù di un’idea autarchica e conservatrice dei rapporti internazionali, per una sinistra autonoma le cose sono molto difficili perché si tratta perciò di ragionare dialetticamente in una situazione complicata e di esercitare l’arte delle distinzioni. E dunque, si tratta di riconoscere la natura progressiva della mondializzazione ma al tempo stesso di mostrare come oggi essa non sia affatto all’ordine del giorno. Perché le modalità peculiari dell’internazionalismo odierno, ovvero della globalizzazione imperialistica statunitense, assieme a quelle che hanno condotto alla convergenza europea, lungi dal costruire un ambiente politico democratico che conduce al superamento delle discriminazioni e delle esclusioni, si presentano semmai come l’ambiente di una nuova forma di egemonismo continentale e di una nuova forma di colonialismo planetario di fronte al quale le democrazie moderne nella forma degli Stati nazionali hanno il diritto e persino il dovere di difendersi.
Come si vede, il problema è assai arduo da maneggiare. I rischi di un approccio semplicistico sono qui assai gravi per la sinistra, perché possono portarla ad avvitarsi in una spirale di regressione culturale. Faccio un esempio. Certamente la moneta unica è una parte di questo problema e l’Euro ha avuto una funzione di compressione dei salari e controllo sociale. Ma prima della moneta unica era forse in vigore il socialismo? Si andava forse verso un miglioramento dei rapporti di forza politici e sociali o già all’epoca si andava verso un peggioramento? Il feticismo dell’Euro e l’atteggiamento che individua in esso tutti i mali mi sembrano le due facce della stessa subalternità. Non c’è il rischio, in tal modo, di assecondare pericolose bizzarrie legate al sovranismo monetarista, lungo un percorso infido nel quale persino le fantasie idiote sul signoraggio trovano ascolto?
Ci troviamo in realtà di fronte a un vero e proprio vicolo cieco, rappresentativo dei problemi più generali della sinistra. E’ chiaro che il fronte degli euro-entusiasti è oggi un fronte egemonizzato a destra in chiave tecnocratica. Nonostante la fenomenologia politica veda le sinistre ufficiali alla sua testa, le politiche europee sono in realtà di estrema destra e anzitutto quella sinistra che gestisce il potere costituisce da tempo l’estrema destra, sul piano sociale. Ma non si pensi di poterne uscire facilmente o che basti agitare la bandiera della rottura dell’Unione per accumulare consenso, perché anche il fronte degli euroscettici è egemonizzato dalla destra, sebbene si tratti di una destra diversa da quella ben educata delle banche e delle assicurazioni. E sarebbe la destra a capitalizzare la fuoriuscita, così come è un’altra destra ad approfittare della situazione vigente. La nostra impassse è tale, perciò, che restando all’interno dei meccanismi dell’Euro andiamo a destra, ma uscendone andiamo ancora e sempre a destra. In un caso e nell’altro, infatti, i rapporti di forza economici e sociali non cambiano con la semplice decisione di rimanere o di uscire. E non c’è nessun automatismo in ragione del quale una scelta o l’altra possa determinare di per sé uno scenario più favorevole per l’aggregazione di un soggetto antagonista.
E’ chiaro, allora: da un lato l’unificazione europea risponde in astratto a una tendenza generale che è progressiva ma rispetto alla quale il capitale si è attrezzato assai bene, mentre il mondo del lavoro no. Il capitale si è dotato da tempo di un coordinamento internazionale, pur nelle sue inevitabili e strutturali divisioni. Il mondo del lavoro non è invece in grado di condurre una battaglia sovranazionale e gli rimane solo il lato della competizione tra segmenti della forza-lavoro (una competizione che in determinate condizioni, come sappiamo, rischia di assumere l’aspetto di una guerra razziale). Dall’altro lato, il superamento degli Stati nazionali è avvenuto non come un movimento di Aufhebung ma nella forma di un vero e proprio scardinamento, come un momento di lotta di classe nazionale e sovranazionale ad un tempo, il cui obiettivo è consistito esattamente nel proposito di ri-sottomettere il lavoro che si era emancipato troppo. Lo Stato nazionale andava assolutamente abbattuto nelle sue prerogative, perché sino a questo momento proprio lo Stato nazionale ha costituito il luogo politico della democrazia moderna. Il luogo, cioè, in cui il fronte del lavoro ha raggiunto il massimo di accumulazione di forze sinora conseguita fino a diventare persino un pezzo dello Stato. La nostra situazione odierna, perciò, non è assimilabile in nessun modo a quella della nascita degli Stati nazionali in Italia e Germania alla fine del XIX secolo, quando l’unificazione, come notava Gramsci, spazzava via residui feudali e creava una situazione di per sé più avanzata sul piano dei rapporti di forza. In questo caso, molto più confuso, l’unificazione è invece un arretramento netto nei rapporti di forza, non un avanzamento. E’ una distorsione nell’ambito di un processo di mondializzazione che è stato deformato nel senso della globalizzazione neoliberale.
Come si vede, ripeto ancora una volta, la situazione è tutt’altro che semplice. Per chi voglia riproporre la centralità della questione nazionale a partire dalla denuncia della divisione imperialistica del lavoro internazionale, non è sufficiente agitare lo slogan dell’uscita dall’Euro. Prima di Maastricht, i rapporti di forza si erano già invertiti nell’ambito della democrazia nazionale e oggi rimarrebbero assai sfavorevoli in un caso o nell’altro. A ciò si aggiunge il fatto che la sinistra è assolutamente impotente: non siamo certamente noi a guidare i processi o a influenzarli, e a poter godere di un esito o dell’altro, ma sono altre forze ben più potenti. Per cui, alla fine, fermo restando che bisogna riportare la questione nazionale al centro del dibattito, questo obiettivo non si esaurisce nel dire se sia meglio stare dentro o andare fuori, bensì consiste nel fare quelle cose che in un caso come nell’altro andrebbero comunque fatte e che invece mancano del tutto perché la sinistra non sembra più capace di farle. E cioè lavorare sul terreno politico, sindacale, culturale, per modificare questi rapporti di forza, sulla base di un progetto nazionale-popolare di lunga durata che sia alternativo a quello delle destre tecnocratiche al potere ma anche a quello, regressivo, delle destre “populiste”.
Se si comprende la necessità di svolgere questo lavoro, prendere posizione sull’Euro e sulla UE (che comunque sono due cose diverse) diventa molto più facile. Un arresto del processo di unificazione monetaria e finanziaria a fronte del suo squilibrio strutturale, infatti, significherebbe un arresto delle dinamiche di aggregazione continentale, che sono molto profonde? Assolutamente no. Molte volte in passato processi simili si sono avviati e interrotti per poi riprendere in forme nuove proprio perché la tendenza di fondo era assai solida. E nemmeno la rottura della architettura finanziaria e monetaria della UE sarebbe sotto questo aspetto una tragedia. Se invece la fuoriuscita dai vincoli di Maastricht non fosse possibile, quel lavoro sarebbe comunque essenziale per sopravvivere in un contesto assolutamente ostile come quello che ci attende nei prossimi anni.
Purtroppo, nella nostra impotenza finiamo per rinunciare all’analisi e per fare semplicemente il tifo per una o l’altra delle soluzioni, rimuovendo il fatto che in entrambi i casi stiamo solo parteggiando per questa o quella frazione delle classi dominanti, che sono le vere protagoniste della contesa. Anche l’idea di un fronte comune con i ceti medi mi sembra in questo momento del tutto illusorio, mancando identità e soggettività definite in un campo come nell’altro.
Liberalismo filosofico e liberismo economico. Parliamo di pratiche e idee del tutto indipendenti oppure siamo in presenza di concetti interdipendenti?
Mi sembra scontato che tra questi due fenomeni ci sia un rapporto di interdipendenza. Su un terreno storico è possibile ricostruire i nessi che nel corso del XIX secolo e soprattutto nella sua seconda metà, nell’ambito delle divisioni e dei conflitti interni al movimento intellettuale e politico liberale – in sintonia con grandi trasformazioni nella struttura dei traffici commerciali internazionali e nelle gerarchie interne alle classi dominanti europee –, hanno segnato l’avvento della teoria del libero scambio. Sappiamo anche che lo stesso Marx ad un certo punto e in un contesto storicamente determinato – ma anche a partire da una precisa concezione dello sviluppo storico e delle relazioni sociali che oggi non dovremmo dimenticare – ha preso posizione a favore del libero scambio, in quanto sinonimo di modernizzazione dei rapporti capitalistici e dunque di un più fluido funzionamento della lotta di classe rispetto alle pastoie ancora semifeudali del protezionismo. E’ una lezione alla quale non possiamo non fare riferimento, nel momento in cui la Cina socialista è impegnata a far riconoscere la propria natura di economia di mercato e a difendere il libero scambio dalle minacce protezioniste di chi vorrebbe scatenare una guerra commerciale. Semmai, proprio questo è il problema oggi: quanto nel cosiddetto liberismo o neoliberismo contemporaneo ha effettivamente a che fare con il libero scambio e in che misura esso non costituisce invece uno scambio strutturalmente iniquo e tutt’altro che libero, a partire dalla articolazione imperialistica della divisione del lavoro e delle gerarchie commerciali internazionali?
Tornando però alla domanda, visto che questo discorso ci porterebbe lontani, a questo proposito io faccio mia l’idea di Benedetto Croce, opposta come è noto a quella di Luigi Einaudi, secondo cui il liberalismo non è semplicemente il lato filosofico di una teoria economica ma qualcosa di più. Esso non rimane soltanto il punto di vista culturale particolare di classi determinate ma è una visione del mondo e dell’individuo che a certe condizioni può andare ben al di là del liberismo o della configurazione che la concreta politica liberale assume in fasi determinate. In questo senso il liberalismo come atteggiamento filosofico può coniugarsi anche con politiche di orientamento diverso. E di volta in volta ha utilizzato politiche economiche liberiste oppure protezioniste, secondo gli interessi del momento.
E però qui finisce il sentiero lungo il quale è possibile a mio avviso seguire Croce, il quale faceva ovviamente una apologia del suo liberalismo ideale, ovvero del liberalismo inteso come filosofia. Croce dimenticava, però, o non voleva vedere, che se dal piano ideale scendiamo su quello dei concreti rapporti storici e politici, il suo liberalismo come religione della libertà universale è del tutto introvabile. Il liberalismo infatti è un atteggiamento culturale che è nato su basi di classe (i liberi, i ben nati o i ben riusciti, distinti da coloro che sono servi o che devono sporcarsi le mani per vivere). Ed è anche un atteggiamento che deve essere universalizzato a forza, perché il punto di vista liberale è stato sin dall’inizio gravato da clausole d’esclusione che non potevano essere superate per evoluzione interna e spontanea di questa filosofia. Parlo dell’esclusione dalla comune umanità, e dunque dallo spazio sacro della libertà, di coloro che per vivere sono costretti ad esercitare il lavoro manuale, e che perciò finiscono per abbrutirsi e divenire simili alle bestie o agli strumenti di lavoro. Oppure dell’esclusione dei sottouomini delle colonie, la cui natura è predisposta alla schiavitù e non può essere certo messa sullo stesso piano di quella dei bianchi. E’ un caso che una grande rivoluzione come quella americana non si ponga il problema della abolizione della schiavitù se non dopo un secolo mentre questo problema è ben presente sin dall’inizio nella Rivoluzione francese?
Certo, pur con tutte queste limitazioni che ne fanno a lungo l’ideologia dell’uomo maschio bianco e proprietario, sono presenti nel liberalismo due aspetti essenziali, che fanno di questa visione del mondo un progresso netto rispetto a quanto c’era prima: l’umanismo, che affida all’uomo e al suo operare il compito di costruire il processo storico; e il riconoscimento dell’individuo nel suo primato rispetto a vincoli comunitari tradizionali e naturalistici. E però, solo il confronto-scontro con la tradizione radicale e quella socialista ha costretto il liberalismo a riconoscere come individuo non solo il lord inglese o il borghese occidentale ma l’uomo in quanto tale. Solo la pressione del radicalismo nato dalla Rivoluzione francese e poi del socialismo e del comunismo novecentesco ha portato al matrimonio tra liberalismo e democrazia. I quali non coincidono affatto, come vorrebbe invece la vulgata ancora oggi dominante (solo la presenza concomitante di una alternativa di sistema ha consentito, assieme al culmine di un ciclo di lotte di classe durato 100 anni, l’affermazione della democrazia moderna e del Welfare State in Occidente). E i quali hanno del resto maturato un rapido divorzio, nel momento in cui ogni alternativa di sistema è stata sconfitta e il liberalismo ha potuto permettersi di riassumere le pose proto-liberali che i nuovi e feroci rapporti di forza tra forti e deboli gli hanno consigliato, sia sul terreno economico (ripristino di forme postmoderne di servitù della gleba e di dipendenza personale) sia su quello politico (bonapartismo postmoderno).
Solo se teniamo conto di queste precisazioni possiamo perciò accettare l’idea che liberalismo sia stato a lungo sinonimo di modernità. E se guardiamo le cose in questa prospettiva, il compito del materialismo storico e del socialismo è stato ed è ancora non quello di sovvertire la modernità in una indefinita palingenesi che faccia tabula rasa di ogni eredità del passato ma di compierla, inverandone i punti più alti e, appunto, universalizzandola. Nell’epoca del declino proto-liberale del liberalismo democratico, il nostro è dunque per tanti aspetti il compito paradossale di salvare e portare a compimento il programma liberale, che nella sua massima estensione coincide con il programma minimo comunista (Gramsci), anche al di là della consapevolezza, della volontà e degli interessi dei liberali stessi.
Ha pienamente ragione sotto questo aspetto il Mito Transpolitico, ovvero la destra postmoderna, la quale denuncia – come faceva la Rivoluzione Conservatrice in Germania con autori come Moeller e anche Heidegger – la continuità metafisica tra marxismo e liberalismo. Questa contiguità non risiede però nella condivisione del progetto dell’homo oeconomicus, come viene detto, e cioè nel fantomatico primato dell’economia sulla politica come su ogni altro aspetto dell’umanità. La continuità o contiguità vanno intese, invece, nel senso assai più nobile dell’appartenenza di entrambe queste tendenze al comune terreno della modernità, della laicità e della libertà individuale coniugata con quella collettiva. Ogni pulsione autoritaria che voglia risottomettere a priori l’individuo al gruppo o alla comunità è invece una mancata soluzione di ciò che non viene considerato un problema. E va respinta in nome del concetto universale di uomo inteso marxianamente come libera individualità integrale, che è tale soltanto nel libero e democratico sviluppo delle relazioni sociali.
(1) Stefano Azzarà è ricercatore di storia della filosofia presso l’università di Urbino. Stefano G. Azzarà (Messina, 26 dicembre 1970) si è laureato in Filosofia presso l’Università di Messina nel 1992 con una tesi dal titolo Pensare nel mondo. Hannah Arendt interprete di Kant. Nel 1993 ha vinto una borsa di studio della Fondazione “Bonino-Pulejo” di Messina, per una ricerca sulla filosofia italiana contemporanea e sulla crisi del pensiero dialettico in Italia. La ricerca è stata svolta presso l’Università La Sapienza di Roma sotto la guida del prof. Giuseppe Bedeschi. Nel 1996 ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca in Filosofia presso l’Università di Urbino, con una tesi su Martin Heidegger. La questione della tecnica tra Rivoluzione Conservatrice e fine della politica. Nel 1998 ha conseguito una borsa di studio biennale di post-dottorato presso l’Università di Urbino. Nel 2000 ha ottenuto un Assegno di ricerca annuale presso l’Università di Urbino. Dal 2000 è segretario della Presidenza della Internationale Gesellschaft Hegel-Marx für dialektisches Denken. Dal 2001 è ricercatore di Storia della Filosofia presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Urbino. Dal marzo 2005 al settembre 2009 è stato rappresentante dei ricercatori nel Cda dell’Università di Urbino. Dal 2008 fa parte del comitato di redazione della rivista “Marxismo Oggi”. Dal 2012 collabora con la Slovenian Research Agency con funzioni di peer reviewer. Dal 2014 è abilitato per la Seconda fascia nel raggruppamento di Storia della filosofia e di Filosofia politica. Dal 2014 è referente del Corso di studio in Scienze dell’educazione presso l’Università di Urbino. Dal 2016 è direttore scientifico della rivista “Materialismo Storico”, della quale cura anche il blog www.materialismostorico.it. Ha scritto numerose monografie e saggi pubblicati su riviste italiane e straniere, reperibili su Iris. Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali, curandone a volte anche l’organizzazione.