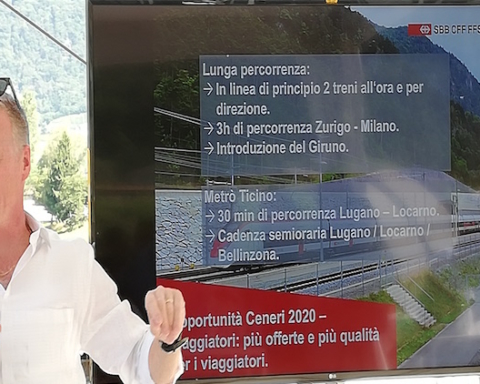Nel 1989, a seguito di alcuni dubbi sull’operato della Polizia Federale (Bundespolizei), fu istituita una commissione parlamentare d’inchiesta ad hoc. Poco tempo dopo, scoppiò quello che divenne famoso come il “Fichenaffäre”, lo scandalo delle schedature. Erano stati collezionati tra i 700 e i 900mila dossier, contenenti innumerevoli informazioni personali riservate; si stimò che circa un cittadino su sette fosse schedato. Poco dopo lo scoppio del “Fichenaffäre”, una nuova commissione parlamentare (1990) constatò che anche il Dipartimento federale della difesa e i Servizi segreti militari stavano raccogliendo materiale riservato. La commissione rivelò l’esistenza sia della P-26, una formazione militare segreta, sia della P-27, un’unità specializzata nella raccolta di informazioni riservate – entrambe interne ai Servizi segreti militari. Nella seconda commissione d’inchiesta – in qualità di co-presidente – sedeva anche Werner Carobbio, che fu consigliere nazionale fino al 1999, fondatore e segretario cantonale dell’ex-Partito Socialista Autonomo (PSA) nonché redattore responsabile del suo settimanale “Politica Nuova” (1965-1992). Con lui parleremo di questo momento di storia elvetica, come anche della nuova Legge sul Servizio di Informazioni, approvata nel settembre 2015 e nei confronti della quale è stato indetto un Referendum.
Riportiamo di seguito l’intervista integrale a Werner Carobbio pubblicata sull’edizione di maggio 2016 del quadrimestrale d’approfondimento marxista #politicanuova, a cura di Aris Della Fontana e Alberto Togni.
1. Quali furono le categorie della società elvetica che, in modo consistente e significativo, vennero prese di mira dalla furia dei dossier? Come si spiega una sorveglianza preventiva così vasta?
Nelle centinaia di migliaia di schede raccolte dalla Polizia federale (Bundespolizei) e poi dal Dipartimento militare, a essere presi di mira furono soprattutto persone di nazionalità svizzera e non, che avevano legami con sezioni del Partito Svizzero del Lavoro (PSdL)1, che erano membri di associazioni quali per esempio le “Colonie libere”2 o attivisti dei movimenti contrari all’armamento atomico, così come gli obiettori di coscienza3.
Il clima, indubbiamente, era quello della Guerra Fredda. È vero tuttavia che la sorveglianza si era estesa a tutti quelli che avevano fatto semplicemente uso dei diritti costituzionali, firmando una petizione o prendendo posizioni che, in qualche modo, si rivelavano critiche nei confronti della difesa nazionale. A tal proposito è innegabile come la raccolta di informazioni fosse completamente sfuggita di mano, trasformandosi così in una registrazione sistematica e maniacale di ogni minimo segnale di dissenso. Emblematico, in quest’ottica, il controllo del Consigliere federale Otto Stich (1984-1995)4, in ragione del saluto da egli portato, a nome del Consiglio federale, ad una conferenza culturale svoltasi a Basilea, il cui argomento – a quanto si ritenne – poteva minacciare la sicurezza nazionale.
Il controllo istituzionale nei confronti di questi uffici era pressoché inesistente. Era attiva una commissione, composta da membri del Consiglio Nazionale e da membri del Consiglio degli Stati, che avrebbe dovuto vigilare sull’operato dei servizi legati al Dipartimento militare. Tuttavia, i meccanismi di funzionamento di questa commissione erano alquanto particolari: per esempio, solo alcuni membri – appartenenti guarda caso ai partiti borghesi – venivano convocati regolarmente (nel caso concreto, Sepp Stappung, Consigliere nazionale del PSS dal 1983 al 1991, non potendovi partecipare in modo adeguato, non disponeva di tutte le informazioni concernenti l’operato degli uffici).
2. La commissione parlamentare a cui lei partecipò constatò che il Dipartimento federale della difesa e i Servizi segreti militari stavano raccogliendo materiale riservato. Emerse peraltro l’esistenza sia della P-26, una formazione militare segreta, sia della P-27, un’unità specializzata nella raccolta di informazioni riservate – entrambe interne ai Servizi segreti militari. Come giudicare e spiegare tutto ciò?
Chiariamo subito il perché del termine P-26. In un rapporto concernente la sicurezza elvetica, al punto 26 c’erano quattro righe che notavano come il governo si fosse impegnato e s’impegnasse a prendere le misure atte a garantire un tale obiettivo. Questa premura va inserita nel quadro del timore di una potenziale invasione, la quale, ovviamente, sarebbe potuta giungere solo dall’Unione Sovietica – e a tal proposito non è per nulla casuale che, durante le esercitazioni militari, ad impersonare il nemico fossero sempre i russi. Il clima storico, dunque, è qui ancora quello caratterizzato dalla Guerra fredda. Questa era l’unica informazione che concretamente possedevamo, ma nessuno sapeva esattamente cosa ci fosse dietro. Scavando, scoprimmo che era stata allestita una sorta di organizzazione paramilitare che, in caso di invasione, avrebbe dovuto organizzare la «resistenza popolare» del paese. Evidentemente, parlare di «resistenza popolare» risulta alquanto fuori luogo e assurdo, dato che essa, per essere effettivamente tale, dovrebbe originarsi dal basso e non, invece, venire architettata e finanziata da ristrette cerchie altolocate.
A capo della P-26 figurava un membro del Dipartimento militare: i finanziamenti messi a disposizione dal Dipartimento – una piccola percentuale dei crediti militari – giungevano su un suo conto personale. Egli, tra le altre cose, aveva il compito di reclutare tutta una serie di personaggi disposti, in caso di necessità, a partecipare a questa «resistenza» – tra questi figuravano anche dei ticinesi. Poteva capitare che queste persone tenessero dei “corsi di formazione”. Quando la commissione d’inchiesta chiese di poter visionare la lista degli aderenti a tale organizzazione, il Consiglio Federale si oppose sostenendo che sussistevano problemi di privacy (molte di queste persone, infatti, partecipavano al progetto senza aver nulla riferito ai propri famigliari). Ma la legislazione prevedeva che l’ultima parola spettasse alla commissione: insistemmo e così si raggiunse il compromesso che permise ai due presidenti della commissione – ovvero il sottoscritto e Carlo Schmid (PPD) – di visionare la lista.
La P-26, inoltre, disponeva di molte strutture ben attrezzate e disseminate in tutta la Svizzera, che fungevano da deposito di munizioni, di armi e di altro materiale.
Come si spiega tutto ciò? Devo dire che Carlo Schmid, di fronte a quanto emerse, si trovò ad essere piuttosto scandalizzato. Da parte mia, invece, ci fu una relativa “tranquillità”: avevo capito come la P-26 non rappresentasse nient’altro che la variante elvetica dell’italiana “Gladio”5. A questo proposito il dubbio era che, nonostante la neutralità, la Svizzera intrattenesse relazioni con la NATO. Sollevammo la questione, chiedendo che il mandato della commissione d’inchiesta fosse esteso, così che potesse recarsi alla sede NATO di Bruxelles. Ma il parlamento non diede seguito all’autorizzazione, optando invece per dare l’incarico di chiarire la questione al Consiglio Federale, il quale stabilì che non vi era alcuna prova a sostegno della citata tesi.
Per quanto concerne la P-27, devo ammettere che si rivelò un‘organizzazione a tratti al limite del ridicolo – anche e soprattutto se paragonata alla ben strutturata P-26. Questo servizio aveva lo scopo di mantenere informata la Confederazione a proposito di differenti situazioni e questioni, consegnando periodicamente fascicoli al Consiglio Federale. Una volta, durante i lavori della commissione, mi capitò di leggere uno di questi fascicoli, il quale riguardava la Mongolia: scorrendo il testo mi resi ben presto conto che esso era, in realtà, poco più che una riformulazione di un articolo recentemente apparso su “Le Monde Diplomatique”.
3. In che modo si deve porre la sinistra rispetto a questi fenomeni? Ad oggi la questione può dirsi risolta, oppure permangono contraddizioni e interrogativi di rilievo circa il diritto alla privacy? A tal proposito, la nuova Legge sul Servizio di Informazioni, approvata nel settembre 2015, getta le basi legali per un corposo ampliamento della sorveglianza preventiva di massa in Svizzera – attuabile, peraltro, sulla base di semplici supposizioni?
La sinistra, dal canto suo, non può far altro che continuare a battersi affinché sia tutelata in modo integrale la privacy dei cittadini. A questo proposito, il referendum contro la Legge sul Servizio di Informazioni costituisce un’azione molto importante – anche se, purtroppo, esso si rivelerà molto probabilmente un disastro, dato il clima vigente. Occorre inoltre pretendere con fermezza un aumento della vigilanza sulle attività di sorveglianza interna. A seguito dell’inchiesta condotta dalla commissione, è stata creata una delegazione della sicurezza, composta da 6 membri (di cui 3 provenienti dal Consiglio nazionale e 3 dal Consiglio degli Stati), che ha il compito di controllare sia il ministero pubblico sia i servizi di informazione del Dipartimento militare. Io stesso facevo parte di questo organo. Devo ammettere che, inizialmente, vi si poteva svolgere un buon lavoro; per qualsivoglia caso, anche il più insignificante, la commissione veniva convocata. Con il passare del tempo, tuttavia, le cose si sono fatte ben più complicate, soprattutto sul versante della metodologia di lavoro: se inizialmente le schedature erano manuali, a seguito dell’introduzione dei sistemi informatici risultava molto più difficile eseguire dei controlli efficaci.
Va poi detto che la questione concernente i servizi segreti non potrà mai dirsi risolta fino in fondo, proprio per il fatto che stiamo parlando di organismi «segreti». In ogni caso, oggi le priorità della sicurezza nazionale sono mutate. I timori e le conseguenti precauzioni non sono più riferiti all’Unione Sovietica e ai suoi “appoggi” interni, bensì al cosiddetto «terrorismo» – e senza dubbio i recenti attentati non fanno che rafforzare questa impostazione. Siamo ovviamente tutti d’accordo sulla bontà di un’azione preventiva volta ad impedire che episodi di terrorismo abbiano luogo sul territorio nazionale. Il rischio, nell’ambito di questa prassi, è però quello di andare ben oltre a quanto effettivamente sarebbe necessario: le ultime modifiche di legge, infatti, prevedono controlli preventivi, intrusione nei sistemi informatici e altro ancora. E, in tal senso, se non è presente un controllo attento ed efficace su questo tipo di operazioni, il rischio probabile è quello che la storia si ripeta. Inoltre, costituisce un importante limite il fatto che il controllo politico, esercitato nei confronti di funzionari a tempo pieno, sia condotto da parlamentari di milizia.
1 L’attuale Partito Comunista della Svizzera Italiana (denominato in precedenza Partito Operaio e Contadino Ticinese e in seguito Partito del Lavoro) è stato sezione ticinese del PSdL dal 1944 al 2014.
2 La prima Colonia libera italiana fu fondata nel 1925 a Ginevra: “libera” stava a significare l’opposizione al regime mussoliniano che voleva fascistizzare le organizzazioni degli emigrati italiani, imponendo la nomina di dirigenti non democraticamente eletti dai soci ma scelti personalmente dal console. Sull’esempio di Ginevra, altre Colonie libere sorsero in altre località Svizzere. Grande impulso alla creazione di nuove Colonie libere fu dato all’indomani del crollo del regime fascista. Negli anni Sessanta e Settanta con l’arrivo di sempre nuove masse di lavoratori italiani in Svizzera, la FCLIS divenne una grande organizzazione dell’emigrazione, stabilendo rapporti di collaborazione con le altre associazioni italiane e di altri Paesi, così come con i sindacati locali ed i partiti della sinistra italiana e svizzera.
3 In Svizzera l’obiezione di coscienza al servizio militare veniva punita con il carcere fino al 1996, quando venne istituito il Servizio Civile.
4 Otto Stich (1927-2012) fu ministro delle finanze della Confederazione, membro del Partito Socialista Svizzero e dell’allora sindacato FCTA.
5 Denominazione con cui è nota un’organizzazione para-militare segreta italiana, collegata con una struttura – denominata “Stay behind” – alla quale partecipavano in funzione anti-comunista Paesi del blocco occidentale, e operante a partire dal secondo dopoguerra.