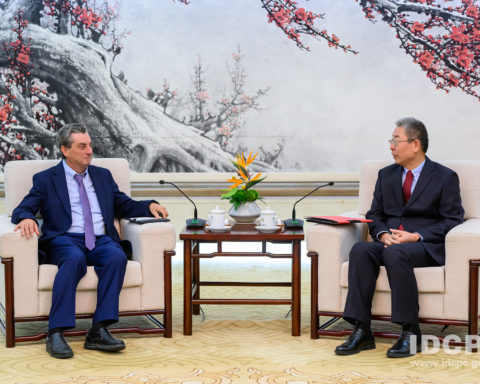Pubblichiamo qui di seguito un articolo di Christopher Mott, ricercatore associato presso l’Institute for Peace and Diplomacy, già funzionario presso il Dipartimento di Stato americano. Una versione più lunga di questo testo è stata pubblicata con il titolo “Woke imperium: The coming confluence between social justice and neoconservatism” nel giugno 2022. Questa versione è tradotta dall’articolo apparso sul numero di gennaio di “Le Monde diplomatique”.
Le grandi potenze nascondono spesso le loro ambizioni strategiche dietro a considerazioni virtuose di portata universale: i diritti dei popoli, la difesa della libertà, la civiltà. Negli ultimi anni, i valori di sinistra sono sempre più mobilitati al servizio degli obiettivi strategici dell’Occidente.
Dare la caccia al terrorismo, promuovere la democrazia, proteggere i popoli… gli Stati Uniti non mancano d’immaginazione per giustificare i loro interventi militari e le loro ingerenze all’estero. Una nuova serie di argomenti viene mobilitata non appena quella precedente ha perso il suo valore. Da alcuni anni, Washington privilegia un registro inedito, quello della giustizia sociale, riciclando le lotte di società in voga in Occidente per legittimare i suoi interventi all’estero. Così, i dignitari del Pentagono e del Dipartimento di Stato, l’intellighenzia dei think tank più influenti, ma anche i rappresentanti delle ONG e gli editorialisti dei grandi media – per farla breve, tutti quelli che contano in materia di politica estera – parlano ormai di lotta contro l’oppressione delle donne, di difesa delle minoranze etniche, di diritti delle persone LGBT… Facendo eco ai temi apprezzati dai giovani diplomati e da certi ambienti militanti radicali, elaborano un nuovo obiettivo strategico, che torna utile per giustificare ogni sorta di ingerenza: la “formazione culturale” (culture forming) sulla base di norme e costumi occidentali.
A prima vista, può sembrare sorprendente che dei temi sostenuti da certi ambienti militanti progressisti – gli ambienti “woke”, secondo l’espressione usata dai media – alimentino delle politiche intervenzioniste ed espansionistiche, spesso armate. Questa tendenza non dovrebbe però sorprendere. Gli Stati Uniti ricorrono da tempo immemore al registro della morale per nascondere le loro mire imperialiste. Sin dal XVII secolo, il puritanesimo anglosassone, con il suo idealismo moralista, costruisce una storia umana basata su narrazioni universaliste. Nella sua versione secolare, questo pensiero è incarnato nella figura di Thomas Jefferson, il terzo presidente americano (1801-1809), che concepiva gli Stati Uniti come un “impero della libertà” che guidava con il suo esempio le altre nazioni del mondo, afflitte dall’ignoranza (1). Un secolo più tardi, il presidente Woodrow Wilson (1913-1921) vide nella prima guerra mondiale, una volta entrato nel conflitto, un occasione per propagare i valori politici dell’America e per definire un quadro di comprensione universale delle relazioni internazionali (2).
Questo tentativo di rimodellare l’ordire internazionale sfociò nella creazione della Società delle Nazioni (SdN) – alla quale gli Stati Uniti finalmente non parteciparono in ragione dell’intransigenza del Senato, repubblicano e isolazionista, e della feroce resistenza del presidente Warren Harding (1921-1923).
All’alba del XXI secolo, era ancora la morale a guidare l’intervenzionismo americano. Alcuni mesi appena dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, l’amministrazione di George W. Bush elargiva in effetti il perimetro della sua missione: non si trattava più soltanto di dare la caccia ad Al-Qaeda e i suoi complici, ma di condurre una “guerra al terrorismo”. Questo progetto utopico pretendeva di pacificare diversi punti caldi del pianeta attraverso operazioni di “regime change” e di “nation building”. Inaugurato in Afganistan, si è esteso all’Iraq, e poi all’insieme del Medio Oriente. Queste spedizioni armate erano spesso esplicitamente giustificate con la promozione della democrazia. Esse comportavano inoltre, come era già stato il caso di altre amministrazioni, una dimensione religiosa che influenzava la definizione delle priorità. Per esempio, l’aiuto allo sviluppo e all’educazione fornito ai paesi africani nel quadro della prevenzione dell’AIDS furono a lungo condizionati dalla centralità del principio di astinenza, un valore caro alla destra cristiana americana. Tali programmi si rivelarono globalmente inefficaci, per non dire controproducenti.
Nel gennaio 2009, l’arrivo di Barack Obama alla Casa Bianca segnò la fine dell’evangelismo dell’era Bush e l’avvento di una prospettiva che si voleva realista. Con il loro voto abbastanza ampio di alcuni mesi prima, gli Americani avevano rigettato la visione messianica di Bush portata dal candidato repubblicano neoconservatore John McCain, decretando così che il “regime change” non era una risposta adeguata alle minacce del XXI secolo. Tuttavia, anziché abbandonare le strategie idealiste del passato, la nuova amministrazione si accontentò di ridefinirne le logiche. All’indomani della “primavera araba” del 2011, gli Stati Uniti e i loro alleati lanciarono così delle operazioni militaria in Libia e in Siria invocando dei motivi umanitari. Questa copertura ideologica s’inscriveva nel quadro della “responsabilità di proteggere” (responsibility to protect, o R2P), un concetto popolarizzato da Samatha Power, la cui partecipazione all’amministrazione Obama segnò la fine del realismo promesso dal presidente e il passaggio ad un approccio più classico della politica estera americana.
In Libia, le conseguenze dell’intervento militare furono disastrose. Privato di un potere centrale, dilaniato da una guerra civile tra fazioni rivali, afflitto da problemi che prima non esistevano, come il terrorismo o la tratta degli schiavi alla luce del sole, il paese è oggi l’archetipo dello Stato fallito.
Finalmente, la politica della R2P ha avuto per effetto di perpetuare ed esacerbare i problemi che pretendeva di risolvere, alimentando il ritorno una violenza sistemica (3). Ma soprattutto, precipitando il fallimento degli Stati implicati, ha essa stessa creato e aggravato le condizioni che rendono necessari nuovi interventi umanitari. Questi ultimi diventano così una sorta di casus belli perpetuo, avviando un circolo vizioso di crisi.
Oggi, in un contesto di fusione tra élite culturali e diplomatiche, la definizione di un’ideologia adeguata per giustificare l’espansione imperialista si trova al cuore della competizione interna tra classi intellettuali. La posta in gioco per queste ultime è di conciliare i loro interessi egemonici con il loro sentimento di superiorità morale – cioè di mostrare al mondo la loro virtù e la loro coscienza delle prove sopportate dalle popolazioni marginalizzate negli Stati da soccorrere, oliando al contempo gli ingranaggi della macchina da guerra.
Questa confluenza, sulla scena diplomatica, tra giustizia sociale e neoconservatorismo, tra difensori dei diritti umani e partigiani dell’intervenzionismo militare della NATO, è apparsa con evidenza all’avvicinarsi dell’elezione presidenziale del 2016, quando numerosi neoconservatori tradizionali cominciarono a capire che la democratica Hillary Clinton era probabilmente la candidata più adatta per realizzare i loro obiettivi, a fronte di un Donald Trump che sosteneva una forma d’isolazionismo. Dopo la vittoria a sorpresa del miliardario newyorkese, questi diversi avvicinamenti si sono cristallizzati in una coalizione che accoppia i due partiti; ormai, dei nuovi think tank riuniscono degli ex-analisti repubblicani con delle figure democratiche eminenti (4).
I media americani [e con loro quelli europei, ndt] hanno largamente seguito questo riallineamento politico. Così l’editorialista neoconservatore Bill Kritstol, propagandista in capo della guerra in Iraq durante l’era Bush, ha potuto ricevere, nel dicembre 2018, le lodi del canale MSNBC (favorevole ai democratici) che lo salutavamo come “woke Bill Kristol” (5). I giornalisti come i militanti ricorrono ormai al lessico della giustizia sociale per svilire le nazioni presentate come rivali e consolidare l’ostilità del pubblico nei loro confronti. Il North American Congress in America latina – un’organizzazione orientata a sinistra ma generalmente piuttosto favorevole agli Stati Uniti – ha per esempio interpretato le manifestazioni che hanno scosso Cuba nell’estate 2021 come principalmente motivate dalla tolleranza eccessiva del governo cubano nei confronti del razzismo anti-neri (6).
Il caso boliviano è ancora più significativo. Il governo di estrema destra che si è installato a La Paz nel novembre 2019 a seguito di un colpo di Stato, con il sostegno degli Stati Uniti, è stato spesso evocato in termini positivi dai media occidentali, la sua dirigente, Jeanine Añez, essendo presentata come una “militante della causa delle donne” (7). Prima di essere battuto alle urne poco meno di un anno più tardi, il governo Añez ha avuto il tempo di prendere delle misure estremamente dure contro le minoranze d’origine amerindiana e i fedeli delle religioni indigene tradizionali. Perseguita per sedizione e per aver causato la morte di una ventina di oppositori, la “militante della causa delle donne” è finalmente stata arrestata e incarcerata…
La retorica “progressista” ha ulteriormente impregnato il discorso atlantista a partire dall’estate 2021, con la fine dell’intervento della NATO sotto comando americano in Afganistan. Era da lungo tempo che i media del mondo intero si disinteressavano di questa guerra cominciata nel 2001. Ma, con la caduta di Kabul e il ritorno al potere dei talebani, le “donne e le ragazze afgane” hanno improvvisamente ritrovato un posto nelle preoccupazioni occidentali – il tema era già stato mobilitato vent’anni fa per giustificare l’intervento militare presso i paesi europei (8). Sempre pronti a evocare i problemi afgani attraverso il prisma delle questioni sociali e dei temi di attualità propri all’America del Nord, i giornalisti occidentali hanno così visto nella cancellazione da parte dei talebani di un murale rappresentante George Floyd (ucciso da un poliziotto americano a Minneapolis nel maggio 2020) un simbolo dell’arretramento delle libertà provocato dalla ritirata delle truppe americane (9). La focalizzazione su questi temi permette di presentare la presa di potere dei talebani come una tragedia che avrebbe dovuto essere evitata dagli Occidentali anziché come la conclusione logica della guerra più lunga della storia degli Stati Uniti.
Il recupero delle cause progressiste a profitto dell’egemonia americana riposa su delle connessioni, di lunga data, tra il mondo della ricerca, i subappaltatori dell’esercito e le agenzie governative. Nella versione iniziale del suo celebre discorso sui pericoli del complesso militare-industriale, pronunciato nel gennaio 1961, il presidente Dwight Eisenhower affermava già che l’università era una forza motrice di questa relazione oligarchica (10). Egli riconosceva ugualmente, con premonizione, che le idee in voga nei campus avrebbero fornito comodi giustificativi per legittimare l’ideologia della mondializzazione e i futuri progetti imperiali a nome della “liberazione”. Il nuovo consenso tra ricercatori e governo intende promuovere una teoria politica fondata su una morale universale, che sacrifica i particolarismi come la sovranità e favorisce l’omogenizzazione culturale del pianeta grazie al ricorso del soft power quanto a quello dell’hard power.
Universalizzare l’esperienza americana
Man mano che guadagna prestigio nei cerchi politici e diplomatici, la retorica imperialista progressista si confonde sempre più con l’immagine internazionale degli Stati Uniti e il loro ruolo di grande potenza. Le frange acquisite ad una visione convenzionale dell’intervenzionismo, ereditato dalla guerra fredda, hanno capito perfettamente l’interesse di utilizzare a dei fini strategici delle lotte apparentemente motivate dalla giustizia sociale, trascurando i contesti culturali e storici che permetterebbero di spiegare diversamente il trattamento della questione delle minoranze: delle nazioni che vivono secondo modi di vita che ci sembrano inaccettabili possono così essere giudicati facilmente come “problematici”, “intolleranti”, giustificando delle sanzioni o delle operazioni militari.
L’abbiamo visto per esempio con il discorso pronunciato nel marzo 2021 davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite dalla rappresentante degli Stati Uniti, Linda Thomas-Greenfield (11). Facendo riferimento in un contesto di politica estera al “Progetto 1619” del New York Times – che invita a tener conto delle conseguenze della schiavitù sulla narrazione nazionale –, Thomas-Greenfield tendeva a universalizzare l’esperienza americana e a dedurne una posizione moralista assoluta per interpretare i fenomeni mondiali. Questo modo di stigmatizzare gli Stati rivali sulla base di norme culturali definite in Occidente si è anche imposto in occasione delle movimentate discussioni sino-americane che si sono tenute in Alaska nel marzo 2021, nel corso delle quali Washington e Pechino si erano vicendevolmente accusati d’ipocrisia in materia di diritti umani. Poi, nel settembre dello stesso anno, l’amministrazione Biden ha promulgato un decreto che prevede l’applicazione di sanzioni contro ogni persona implicata nelle atrocità commesse nel Tigray, una regione del nord dell’Etiopia in preda ad una guerra civile. Il testo menzionava esplicitamente la natura etnica delle violenze e il loro impatto specifico sulle donne per giustificare l’ingerenza americana. E la lista continua: la Nato ha organizzato un “Dibattito sulle questioni di genere e le minacce ibride” lo scorso febbraio (12); il mese seguente, gli Stati Uniti decidevano di annullare le discussioni previste con i Talebani sugli averi confiscati, adducendo come motivo che il governo di Kabul aveva annunciato di non riaprire le scuole per le ragazze.
Se queste politiche dovessero continuare, finirebbero probabilmente per creare un nuovo metodo che permette di delegittimare certi Stati agli occhi dei popoli occidentali, che condividono delle norme socioculturali comparabili. Questa svolta ideologica implica anche un allineamento sul ritmo mediatico, che può nuocere ad un esame sereno dei fondamenti strategici delle politiche condotte e dei loro benefici per le popolazioni che si dice di voler assistere. Lascia inoltre presagire una nuova generazione di politici più integrata all’opinione della maggioranza, quella della gioventù in particolare, che avvicinerebbe così i militanti della società civile agli obiettivi dello Stato.
Tutto ciò lo si può constatare dall’inizio della guerra russo-ucraina nel febbraio 2022. Certi commentatori hanno messo l’accento sul fatto che, se l’Ucraina non ha davvero di che vantarsi per la sua politica nei confronti delle minoranze LGBT, la Russia fa ancora peggio. Oltre a mettere la barra molto in basso, un caso del genere mostra anche chiaramente che la questione LGBT viene manipolata dai gruppi mediatici favorevoli all’intervenzionismo sotto l’angolo della sua utilità in termini di soft power (13). Un mercato mediatico esiste già per questo tipo di analisi. Nel maggio 2022, The Atlantic, una pubblicazione generalmente pro-intervenzionismo, augurava una “decolonizzazione” della Russia. La storia multietnica di questo Stato veniva comparata al colonialismo di epoca vittoriana, cosa che giustificava di smantellarlo con un operazione di “regime change” (14)…
L’imperialismo liberale ha chiaramente interesse a descrivere la politica estera americana come progressista e a caratterizzare le nazioni ostili come intolleranti e reazionarie. Questo uso selettivo delle cause progressiste spalanca la porta agli interventi in una lunga lista di zone problematiche del Sud del mondo, rinforzando al contempo una narrazione nazionale che presenta queste operazioni come benefiche e moralmente legittime. È facile in seguito affermare che i rivali stranieri che criticano queste politiche sono “dal lato sbagliato della storia”, “opposti al progresso”, “diabolici” – tutte parole in voga sia nel Pentagono che nel Dipartimento di Stato. Negli anni a venire, Washington insisterà probabilmente su questi valori nelle sue relazioni con degli Stati che cerca di indebolire e nelle regioni dove vuole estendere la sua presenza militare. Parallelamente, questi valori saranno senza dubbio sistematicamente messi da parte quando si tratterà di nazioni amiche, come l’Arabia Saudita, esponendo gli Americani e i loro alleati a delle accuse d’ipocrisia, che indeboliranno ancor di più la loro presunzione di virtù morale.
Da quando la CIA, all’inizio della guerra fredda, sostenne finanziariamente degli artisti per promuovere dei valori liberali associati all’eccezionalismo americano (15), la classe dirigente americana sa utilizzare perfettamente i venti culturali dominanti nell’Ovest per difendere la sua visione della politica estera e i suoi interessi securitari facendoli passare per “interesse nazionale”. Nei fatti, le istituzioni statali mantengono la carota delle sovvenzioni, delle promozioni e della formazione professionale per favorire l’emergenza di un pensiero di gruppo sistemico in seno alla burocrazia, favorendo l’internazionalismo liberale e fabbricando il consenso attorno al mantenimento della supremazia americana nel mondo. Per quel che concerne le reti di reclutamento e di promozione delle élite, il loro ruolo è capitale tanto per rinforzare il prestigio delle istituzioni che per intrattenere una cultura del consenso strategico, quest’ultima essendo in seguito perfezionata e diffusa da un esercito di militanti e di gruppi di interesse estremamente visibili ed esperti nell’uso dei media.
Concettualizzare la politica (inclusa la politica estera) sotto l’angolo della giustizia sociale è diventato un riflesso per la classe diplomata che occupa l’essenziale dei posti di management intermedio in seno alle agenzie governative, alle imprese mediatiche e alle società private. Tuttavia, come le banche d’investimento o i fabbricanti d’armi non rinunciano a parte dei loro profitti quando impugnano i simboli LGBT o Black Lives Matters (a dei fini essenzialmente promozionali), la CIA e il Dipartimento di Stato possono a loro volta mostrare pubblicamente il loro impegno in favore delle cause progressiste del momento senza rinnegare le loro ambizioni imperialiste. Anzi, meglio: il processo di professionalizzazione permette al personale attuale e futuro di appropriarsi queste esibizioni di virtù e di propagarle. Per coloro che aspirano ad un’assunzione o una promozione, questo è uno dei modi migliori per segnalare la propria identificazione con gli obiettivi dell’istituzione. Pierre Bourdieau lo chiamava “capitale culturale”, definito come la “famigliarità con la cultura legittima di una società”. Si traduce con un insieme di saperi, competenze, usi e qualificazioni che sottolineano l’appartenenza alla classe dominante.
Tuttavia, coloro che preferirebbero vedere gli Stati Uniti ingaggiarsi in una politica estera più realista e più prudente non possono che constatare che il nuovo ethos di giustizia sociale adempie solo parzialmente o per nulla alla funzione che hanno avuto in passato la promozione della democrazia o la R2P: questo discorso moralista legittima tutte le azioni militari e diplomatiche intraprese in suo nome e discredita al contempo le critiche che potrebbero essergli opposte. Ma il nuovo imperialismo della virtù è forse ancora più destabilizzante perché, oltre alla ristrutturazione politica dei paesi “nemici”, cerca di ottenere la loro sottomissione culturale totale. Un processo che, con il tempo, potrebbe radicalizzare ancora di più i paesi del Sud, non solo contro l’America, ma anche contro il liberalismo e il progressismo in quanto tali. Si vedono già delle nazioni con pochi interessi in comune, al di là della loro ostilità alle ingerenze americane, coalizzarsi contro l’egemonia dell’imperialismo liberale in nome della loro sovranità statale e della loro civiltà (16).
Avvertimento ai progressisti
Da un punto di vista storico, queste evoluzioni non sono né inedite né esclusive agli Stati Uniti. Nel XVII e XVIII secolo, l’Impero britannico ha incoraggiato il commercio mondiale degli schiavi per dei motivi tanto finanziari quanto coloniali, prima che la causa anti-schiavitù, a seguito dei progressi dell’industrializzazione in epoca vittoriana, non divenne un modo per ridefinire l’espansione imperiale in termini di dovere morale (la “missione civilizzatrice”, il “fardello dell’uomo bianco”). L’imperialismo liberale sotto direzione americana sembra funzionare secondo una logica simile: le azioni umanitarie concernono spesso delle regioni dove hanno già avuto luogo degli interventi occidentali, e creano le condizioni che giustificheranno futuri interventi, producendo così una spirale di conflitti perpetui e insolvibili. I casus belli motivati dalle considerazioni di giustizia sociale hanno un’utilità evidente per chi si nutre delle disposizioni espansioniste. In tal senso, questa analisi può essere letta come un avvertimento ai militanti progressisti: il complesso militare-industriale è perfettamente in grado d’assimilare il vostro linguaggio e di metterlo al servizio dei propri obiettivi. E si può sin d’ora scommettere che se questo paravento ideologico che oggi permette di giustificare una politica estera aggressiva e degli interventi militari in terra straniera cesserà di essere considerato funzionale, sarà a sua volta prontamente rimpiazzato da una nuova retorica. E il ciclo ricomincerà.
Note:
(1) Robert W. Tucker and David C. Hendrickson, “Thomas Jefferson and American foreign policy”, Foreign Affairs, New York, primavera 1990.
(2) Milan Babik, “George D. Herron and the eschatological foundations of Woodrow Wilson’s foreign policy, 1917-1919”, Diplomatic History, vol. 35, n° 5, Oxford University Press, novembre 2011.
(3) Si veda Anne-Cécile Robert, “Origines et vicissitudes du ‘droit d’ingérence’”, Le Monde diplomatique, mai 2011.
(4) Glenn Greenwald, “With new DC policy group, dems continue to rehabilitate and unify with neocons”, The Intercept, 17 luglio 2017.
(5) The Beat with Ari Melber, “Fat Joe and woke Bill Kristol”, MSNBC, dicembre 2018.
(6) Bryan Campbell Romero, “Have you heard, comrade? The socialist revolution is racist too”, North American Congress in Latin America, agosto 2021.
(7) “Women’s activist Jeanine Anez takes the reigns in Bolivia”, The Australian, Sydney, novembre 2019.
(8) “CIA report into shoring up Afghan war support in western Europe”, WikiLeaks, marzo 2010.
(9) Akhtar Mohammed Makoii, “The soul of Kabul: Taliban paint over murals with victory slogans”, The Guardian, Londra, 7 settembre 2021.
(10) Henry A. Giroux, University in Chains: Confronting the Military-Industrial-Academic-Complex, Routledge, Londra, 2007.
(11) Linda Thomas-Greenfield, “Remarks at an UNGA commemoration on international day for the elimination of racial discrimination”, US Mission to the United Nations, New York, marzo 2021.
(12) “Deep dive recap: Exploring gender and hybrid threats”, OTAN, Bruxelles, febbraio 2022.
(13) J. Lester Feder, “The fight for Ukraine is also a fight for LGBTQ rights”, Vanity Fair, marzo 2022.
(14) Casey Michel, “Decolonize Russia”, The Atlantic, Washington, DC, maggio 2022.
(15) Frances Stonor Saunders, The Cultural Cold War: The CIA and the World of Arts and Letters, The New Press, New York, 2013.
(16) Benjamin Norton, “Venezuela and Iran sign 20-year cooperation plan, Maduro pledges ‘joint anti-imperialism struggle’”, Multipolarista, 11 giugno 2022.